Migrazioni.
Scenari per il XXI secolo
Convegno Internazionale
Roma, 12-14 luglio 2000
Processi globali e forme di governo delle migrazioni
in Italia e in Europa. Una sintesi delle ricerche
A cura del Censis
Al presente documento hanno lavorato, su coordinamento di Carla Collicelli,
Rosario Sapienza, Matteo Lariccia, Jonathan Chaloff
Roma, luglio 2000
Il Censis, Centro Studi Investimenti Sociali, è una Fondazione di ricerca socioeconomica fondato nel 1964. Da più di trent’anni svolge una costante attività di studio, consulenza, valutazione e proposta nei settori vitali della realtà sociale, dalla formazione, al lavoro, al welfare, alle reti territoriali, all’ambiente, all’economia, allo sviluppo locale e urbano, al governo pubblico, alla comunicazione e la cultura. Nel corso degli anni, tale attività e presenza culturale ha ottenuto un continuo riconoscimento di ruolo e autorevolezza che si è manifestato attraverso un crescente apprezzamento da parte degli osservatori economici e sociali, dei soggetti istituzionali, degli organi di informazione italiani e stranieri. Le attività di ricerca del Censis rispondono a un modello - del tutto originale in Italia - di complessiva equidistanza fra uno stile rigidamente accademico e una impostazione esclusivamente operativa degli obiettivi di ricerca.
Carla Collicelli dal 1980 lavora presso il Censis, dal 1984 al 1993 come responsabile del settore delle politiche sociali - si è occupata, tra l’altro, di emigrazione, di welfare, di tossicodipendenza, di previdenza, di parità uomo-donna - e dal dicembre 1993 come vice direttore generale. Consulente dell’Ocse, del Consiglio d’Europa, della Cee, dell’Unesco, del Consiglio dei Ministri, della Camera dei Deputati, del Cnel e di altre associazioni e organismi esteri, nazionali e locali. Conta numerose pubblicazioni, sia all’interno della produzione Censis, che all’esterno.
Rosario Sapienza, antropologo, svolge attività di ricerca, progettazione, valutazione e formazione nel settore dell’immigrazione, dei processi e fenomeni culturali dei media e della comunicazione, della criminalità. È ricercatore associato del Censis dal 1995.
Jonathan Chaloff, psicologo, dal 1997 conduce ricerca per il Censis sulle politiche e le strategie dell’accoglienza degli immigrati in Italia. Dal 1999 coordina un gruppo di lavoro dell’Organismo nazionale di coordinamento delle politiche per gli stranieri presso il Cnel.
Matteo Lariccia, giurista, dal 1998 collabora con il Censis alle ricerche sulle politiche italiane e comunitarie dell’immigrazione e sui diritti degli immigrati.
Presentazione 5
I dossier di ricerca 6
Introduzione - Fra la sfida di nuovi scenari e la ricerca di nuovi assetti 8
parte i - le migrazioni nel quadro globale
1. I grandi spostamenti di popolazione e le nuove linee evolutive 16
1.1 Le cause delle migrazioni 17
1.2 Dalle tipologie alle politiche di accoglienza 21
1.3 Caratteri e tendenze recenti del fenomeno migratorio 26
2. La politica internazionale 28
2.1 La linea di approccio integrato: programmazione dei flussi e azione sulle cause 29
2.2 Le nuove frontiere della cittadinanza" 31
parte ii - le migrazioni in europa
1. Dall’Europa delle migrazioni all’Europa dell’integrazione: un processo per tappe 35
1.1 1973: punto di svolta delle politiche migratorie in Europa 35
1.2 I flussi degli anni Ottanta 37
1.3 1989: la rottura dell’ordine bipolare 38
1.4 1992: tra "Fortezza-Europa" ed "Europa dei popoli" 39
2. La discontinuità 43
2.1 Il modello "continentale" 43
2.2 Il modello mediterraneo 44
2.3 Due modelli a confronto 44
3. Le linee di convergenza 47
3.1 Due modi di osservare la convergenza 47
3.2 L’osservatorio sociale 47
3.3 L’osservatorio politico-istituzionale 48
3.4 La sperimentazione del Sistema Schengen 49
3.5 Il Trattato di Amsterdam e la strategia del vertice di Tampere 50
3.6 Prospettive 51
parte iii - le migrazioni in italia
1. La presenza e il ruolo degli immigrati in Italia 54
1.1 Un fenomeno "strutturale" ma poco "strutturato 54
1.2 Migrazioni e mercato del lavoro 59
1.3 I richiedenti asilo e i rifugiati 64
1.4 Le catene migratorie 65
2. L'"integrazione": ruolo dello Stato e degli enti locali 71
2.1 Dai "due pedali" al modello della "transizione accompagnata" 71
2.2 Inserimento "organico" nel mondo del lavoro 72
2.3 Le politiche di accoglienza per i rifugiati 73
2.4 Le politiche di welfare 74
2.5 Il ruolo degli enti locali e la spinta dal basso 81
2.6 Oltre il locale 83
Questo rapporto, curato dalla Fondazione Censis, contiene una sintesi e una prima lettura interpretativa del lavoro di documentazione promosso dall’Agenzia romana per la preparazione del Giubileo in occasione del Convegno Internazionale "Migrazioni. Scenari per il XXI secolo", che si svolge a Roma il 12-14 luglio 2000, e delle sue tre sessioni tematiche di approfondimento:
- "Le migrazioni culturali. Arte e gente in movimento", a Firenze dal 27 al 30 settembre 2000;
- "Migrazioni e società multiculturale. Le regole dell’integrazione", a Napoli dal 9 all'11 novembre 2000;
- "Migrazioni, mercato del lavoro e sviluppo economico", a Milano dal 23 al 24 novembre 2000.
Il Convegno Internazionale è una delle principali iniziative culturali promosse dall’Agenzia nell’anno del Giubileo. Se per i cristiani il Giubileo ha soprattutto un significato di celebrazione religiosa, questo evento chiama anche il mondo laico a una riflessione sulla giustizia sociale, sulla solidarietà e sull’apertura nei confronti dell’altro.
La scelta del tema delle migrazioni, per una iniziativa di riflessione che interessa il futuro della società, sottolinea l’importanza che gli spostamenti di popolazione stanno assumendo nel quadro dei nuovi rapporti economici mondiali e il rilievo che le tematiche dei diritti umani, dello sviluppo economico e della crescita della società multiculturale hanno assunto nell’ultimo decennio e avranno nel prossimo secolo.
L’attività di documentazione promossa dall’Agenzia ha l’obiettivo di esaminare queste tematiche e contribuire a identificare le possibili linee delle politiche migratorie in Italia e in Europa nei prossimi anni, presentandole in modo accessibile anche ai non specialisti.
Il lavoro svolto offre molti interessanti contributi alla ricerca specialistica, ma il suo obiettivo fondamentale è l’informazione al pubblico interessato alla questione migratoria. Nonostante il carattere divulgativo, il lavoro svolto ha raggiunto notevoli dimensioni e richiede pertanto un impegno da parte del lettore.
Per facilitare il compito del lettore, l’Agenzia ha chiesto alla Fondazione Censis di svolgere un lavoro di sintesi e di interpretazione delle ricerche realizzate. Questo rapporto costituisce pertanto un importante complemento delle ricerche svolte e una guida indispensabile alla lettura del materiale, che viene inquadrato in un modello interpretativo e ordinato per tematiche e aspetti settoriali.
Nel ringraziare la Fondazione Censis per la collaborazione fornita e per l’impegno con il quale è stato realizzato questo contributo, l’Agenzia esprime l’auspicio che lo sforzo di ricerca condotto possa aiutare la comprensione del fenomeno e il compito di definizione delle politiche necessarie a governarlo.
Francesco Bandarin
Roma, luglio 2000
Elenco dei dossier realizzati dall’Agenzia romana per la preparazione del Giubileo in vista del Convegno Internazionale, "Migrazioni. Scenari per il XXI secolo", per area tematica e con indicazione degli autori.
Parte i - le migrazioni nel quadro globale
Migrazioni e formazione delle società moderne
Marco Breschi e Alessio Fornasin
I movimenti di popolazione nel mondo contemporaneo
Antonio Golini
La dimensione quantitativa del fenomeno migratorio
Caritas Diocesana di Roma
L’economia delle migrazioni
Centro Europa Ricerche, Cer
Le migrazioni internazionali e la cooperazione economica
Centro Italiano di Formazione Europea, Cife
Migrazioni e diritto internazionale
Giandonato Caggiano
Parte ii - le migrazioni in europa: scenari e politiche
Le migrazioni interne in Europa
Centro Italiano di Formazione Europea, Cife
Il governo dei processi migratori nel quadro europeo: obiettivi, strumenti, problemi
Centro Studi di Politica Internazionale, Cespi
Le migrazioni intellettuali in Europa e in Italia
Lisa Francovich
Immigrazione e cittadinanza in Europa
Fondazione Nord Est
Parte iii - l’italia e le migrazioni internazionali
L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne
Enrico Pugliese
Normativa europea e italiana in materia di immigrazione
Giandonato Caggiano
Migrazioni e politiche locali: l’esperienza italiana nel quadro europeo
Centro Studi di Politica Internazionale, Cespi
Migrazioni e previdenza sociale in Italia
Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, Inps
La condizione degli immigrati in Italia
Francesco Carchedi
Migrazioni e sicurezza in Italia
Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno
Immigrati, territorio e politiche urbane. Il caso italiano
Pierluigi Crosta, Andrea Mariotto e Antonio Tosi
Migrazioni e salute in Italia
Caritas Diocesana di Roma
Parte iv - aspetti e problemi del fenomeno migratorio
Integrazione e identità dei minori immigrati
Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Social, Iprs
Strumenti del credito e migrazioni
Centro Europa Ricerche, Cer
L'immigrazione a Roma. L'esperienza della Caritas
Caritas Diocesana di Roma
Ruolo della Chiesa italiana nell'assistenza ai migranti
Fondazione Migrantes
Introduzione
Gli anni che hanno preceduto il cambio di secolo hanno portato importanti cambiamenti. La rottura di quello che oggi chiamiamo "equilibrio bipolare" ha liberato tensioni che dinamizzano, talvolta dolorosamente, l'intero pianeta. L'economia ha marcato grandi e piccole rivoluzioni, quella elettronico/digitale, quella finanziaria, quella del terziario, quella della flessibililità e delocalizzazione lavorativa, quella della globalizzazione dei sistemi monetari e degli investimenti. Gli stessi fronti interni dei paesi a economia avanzata hanno profondamente mutato le loro forme tradizionali, dando vita a nuovi, precari assetti di aggregazione, consenso e concertazione.
L'Italia, sempre più comprimaria nella partecipazione a questi grandi eventi, si trova oggi a metà corsa, in parte soddisfatta di quanto realizzato, in parte preoccupata, più che per la fuga in avanti - "dentro" l'Europa, l'economia mondiale, i tavoli di concertazione internazionale -, per la direzione complessiva cui tendere da ora in avanti.
L’Italia si trova a dover rispondere, anche sul piano internazionale, alle urgenze e alle "crisi", e allo stesso tempo avverte improrogabile l'esigenza di uno sguardo più ampio, capace di abbracciare il senso complessivo delle scelte, delle azioni, delle prese di posizione, che si chiede di esprimere.
Di immigrazione è molto difficile parlare compiutamente. Ancor più complesso è parlare di migrazioni in generale. Ciascuna migrazione rappresenta un "fatto sociale totale" attraverso cui traspare una complessità globale, un sistema privo di confini e ormai totalmente interconnesso, l'indissolubile concatenazione che dal micro - il degrado sotto casa - ci porta ai grandi drammi consumati altrove e rappresentati in televisione.
Ed è proprio da questa impellenza a guardare oltre che nasce la sfida che l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo ha lanciato a istituzioni, mondo accademico, società nel suo complesso. Una sfida che mira a "fare il punto" su questa scivolosa materia, nell'intento di distinguere ciò che non è bene discutere ulteriormente da ciò che pretende viceversa un serio e circostanziato dibattito.
Sarebbe ingenuo negare che il dibattito sull'immigrazione in Italia sia già compiuto. Esso ha prodotto importanti risultati e ha posto promettenti premesse: con una legge "quadro" (finalmente) sull'immigrazione; con una capillare sensibilizzazione istituzionale, che chiama in causa trasversali competenze interministeriali; con la creazione di organi di studio e coordinamento; con la progressiva valorizzazione degli sforzi compiuti da regioni, province, comuni; con la disponibilità all'ascolto di vecchie e nuove agenzie di rappresentanza; persino con il tentativo della "manutenzione" della percezione pubblica sul delicato fenomeno.
Ma proprio perché tutto ciò è stato fatto, le sfide non sono più le stesse, gli obiettivi si sono spostati innanzi e l'esigenza di una prospettiva di medio periodo si fa più incalzante. L'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo ci invita, pertanto, a pensare all'immigrazione in Italia da qui a dieci anni, e ci costringe a una riflessione cauta, composta e prudente. Una riflessione all'ombra di una grande e unanimemente condivisa premessa: dal contesto europeo non é più possibile prescindere. L'azione italiana dovrà fare i conti con un processo - fortemente auspicato - di convergenza delle politiche europee in materia di immigrazione e, come ogni Stato in Europa, sta lavorando su una piattaforma in movimento, all'interno di un processo europeo in atto, le cui mete non sono ancora del tutto evidenti, né codificate, né (forse) sufficientemente condivise.
È legittimo pertanto ragionare sulla situazione in Italia, anche se durante i lavori di preparazione degli eventi e della documentazione il comitato organizzatore si é chiesto se le nostre riflessioni non fossero troppo Italy oriented, ma a condizione che le questioni siano collocate ciascuna nel proprio contesto, per definire un più stretto legame tra quadro demografico, fabbisogni di capitale umano e sviluppo delle relazioni internazionali con i paesi di emigrazione, per collegare le politiche del lavoro con le politiche migratorie e queste ultime con le politiche di cooperazione.
Ragionare sull'Italia significa ragionare innanzi tutto sull’Europa, e poi sulle strategie di cooperazione internazionale, e poi, ancora, su problematiche di respiro viceversa squisitamente locale. Occorre lavorare allo sviluppo di una vera politica europea, con propri obiettivi, strumenti e istituzioni, che vada al di là della logica degli accordi tra paesi membri, che conservano la propria autonomia e la propria sovranità in materia, partendo, ad esempio, dalla armonizzazione delle politiche di ricongiungimento, asilo, concessione dei titoli di soggiorno e dallo sviluppo di alcune norme a carattere extraterritoriale.
Forse proprio per questo motivo il dibattito, la riflessione, la stessa produzione normativa, le solide premesse e l’articolata riflessione, non hanno ancora prodotto i risultati sperati, specie in Italia. È ancora presto per fare bilanci, ma i problemi sembrano almeno in parte ancora lì sul tappeto, più vivi e scoperti che mai: il tasso di irregolari è stimato ancora al di sopra dei livelli di guardia; l’inserimento nel mercato del lavoro resta subordinato e marginale; la questione dei rifugiati si fa allo stesso tempo più impellente e più complessa, e una normativa italiana in materia tarda ad arrivare; le pericolose commistioni fra immigrazione, irregolarità e criminalità più o meno organizzata restano di delicata importanza, anche per via dell’impressione che suscitano presso l’opinione pubblica; i percorsi di accesso alla cittadinanza reale e ai meccanismi di rappresentanza restano macchinosi e impervi.
Il Dipartimento per gli Affari Sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha consacrato il 1999 "Anno dei nuovi cittadini". Nel 1998 i "nuovi cittadini" (gli ammessi alla cittadinanza italiana) fra gli immigrati in Italia sono stati appena 9.843, di cui l’89% ha conquistato la cittadinanza solo grazie al matrimonio con un italiano. Non c'é stato dunque ancora il tempo "tecnico" per rendere attuativo il Testo Unico sull’immigrazione, col risultato che lo scarto fra paese "reale" e paese "formale" resta ampio ed evidente.
Da un lato è necessario allora andare avanti, dando consistenza ai propositi espressi e rispondendo all’incalzare dei problemi, ma dall'altro è cruciale alzare la testa e guardare oltre, alla direzione complessiva, e contribuire alla formulazione delle strategie di respiro europeo e internazionale, in una fase di delicata riformulazione degli assetti civili, ideologici, macro-politici e macro-economici.
I ventidue dossier tematici prodotti dall'Agenzia, e affidati alla competenza di esperti italiani fra i più qualificati nei vari settori specifici e tangenziali al fenomeno dell'immigrazione (di cui questo testo costituisce una sintesi ragionata), assolvono lo scopo di aggiornare il quadro, ponendo le questioni urgenti e improrogabili in primo piano e distinguendole da ciò che, controverso in passato, non lo é più alla luce del verificarsi di fatti più recenti. Una lettura comparata dei dossier permette quest'esercizio di aggiornamento, di riformulazione fra il "condiviso" e il "controverso", fra ciò che può essere dato per assodato e ciò che si impone come ambito delle nuove sfide.
a) Fra ciò che non può più essere discusso, troviamo innanzi tutto il ruolo strutturale dell'immigrazione, nel sistema italiano e nella sua connessione con l’Europa e con le aree geografiche contigue, l'Est Europa o il Mediterraneo, oltre che, naturalmente, con gli scenari globali più allargati.
b) Non può essere più messo in discussione anche l'esplodere della complessità del fenomeno immigratorio in Europa, il diversificarsi della sua configurazione in fatto di provenienza, di cause determinanti, tipologie di stanziamento, mobilità, inserimento lavorativo, distribuzione territoriale, bilanciamento demografico per sesso ed età, complessivo dinamismo e connaturata propensione al mutamento.
c) La spinta crescente alla legalizzazione e "normalizzazione" dei flussi e delle presenze comporta un aumento della quantità di emigrati che si affacciano in Europa e in Italia, a cominciare dal sistema delle "quote" e dall’incremento dei ricongiungimenti familiari. Intanto, l’aumento delle dimensioni complessive del fenomeno, nonché quello di alcuni flussi di provenienza, porta a una crescita della criminalità organizzata legata ai flussi (droga, tratta, prostituzione, racket, ecc.) e a intrecci criminali tra gruppi italiani e stranieri.
d) Anche le caratteristiche dei movimenti e dei loro fattori di spinta continuano a cambiare. Hanno e avranno ancora peso nei prossimi dieci anni la contiguità territoriale, l’emigrazione transfrontaliera, le catene familiari e di villaggio. Accanto a ciò va rafforzandosi però il peso dei bacini marini di confine e il conseguente problema dell’addensamento litoraneo dei flussi; i focolai di crisi politica come fattori di espulsione drammatica; la circolarità di flussi instabili e di "andirivieni"; i fattori immateriali di attrazione, dai messaggi dei mezzi di comunicazione di massa, alle affinità religiose.
e) Importanti cambiamenti si prospettano anche sul piano del modello occidentale di sviluppo, al punto che la crescita economica dell’occidente e i suoi meccanismi tradizionali rischiano di cadere in crisi. Essi saranno sempre più legati ai saldi e agli equilibri tra territori e comunità diverse, in termini di investimenti, rendite, rimesse, flussi di manodopera, flussi di popolazione non lavorativa, piuttosto che a meccanismi interni e a ricchezze autoprodotte.
f) Se, allora, l'ambito in cui interagire col fenomeno non é solo quello nazionale e se, ancora, l’immigrazione non é più solo immigrazione "da lavoro" - tipologia peraltro già tormentata dai contorsionismi del ciclo "post-fordista" di sviluppo economico - emerge come assodata anche una "doppia anima" dell’accoglienza europea ai migranti.
La politica di accoglienza europea si dipana attraverso due aspirazioni, fra loro contraddittorie: da un lato la vecchia vocazione all'accoglienza per motivazioni utilitarie ed economiche e per il reciproco vantaggio di un'immissione di mano d'opera funzionale allo sviluppo; dall'altro l'istanza dell'accoglienza umanitaria, in una sempre più accentuata prospettiva di "protezione", "tutela" e attiva partecipazione dell’Europa e del mondo occidentale alla ricomposizione di un equilibrio ormai planetario.
Da un lato, paesi ricchi, con forte calo demografico e richiesta di manodopera a basso costo si trovano contigui ad aree povere che registrano grande sviluppo di popolazione, come il Nord Africa e l’Africa sub-sahariana. Per molti di questi paesi l’emigrazione di popolazione è un determinante fattore di sviluppo, in quanto incide sulla disoccupazione, sulle entrate economiche e sulle risorse umane di rientro.
Dall’altro, la destabilizzazione politica ed economica contribuisce anch’essa a generare flussi crescenti di rifugiati, che in parte si confondono con i processi migratori legati alle motivazioni economiche, che, solo in minima parte prevedibili, innescano meccanismi di "lungo periodo".
Che l'Europa, e con lei l'Italia, voglia rispondere a entrambe le spinte, assecondando con pari determinazione la sua doppia vocazione "utilitaria/solidarista", resta fuori di dubbio, come pochi dubbi restano sulla condivisa necessità di trovare la strada più breve, e meno onerosa, per la regolarizzazione progressiva della popolazione già immigrata nei paesi di accoglienza.
g) Altro aspetto condiviso, non solo dai lavori di ricerca promossi dall’Agenzia ma anche dalle analisi di esperti e osservatori esteri, é la convinzione che il caso italiano sia in un certo senso cruciale e unico, nel panorama generale. L’impatto di un processo particolarmente rapido di nuovi flussi di recente immissione compensa una densità di immigrazione fra le più basse dell’Unione Europea; la composizione sfrangiata della popolazione immigrata in Italia, in quanto a provenienza, non rende l’Italia paragonabile né agli esempi "classici" di immigrazione dell’Europa continentale né all’attuale contesto europeo-mediterraneo; il tanto celebrato "modello italiano" d’impresa e di sviluppo, connotato da flessibilità e radicamento territoriale, propone modelli inediti di inserimento, che sembrano trovare anche una facile sponda nelle amministrazioni locali, a oggi monopoliste, insieme al privato sociale, delle politiche di integrazione per gli immigrati; al ruolo di stimolo, in qualche caso di traino e di eccellenza, giocato dal nostro paese in ambito europeo, continua a sovrapporsi una non sanata debolezza delle frontiere di "prima linea".
L’Italia non può allora limitarsi a importare esperienze e adottare strategie già sperimentate altrove, in quanto si trova, suo malgrado, a giocare un ruolo pilota di "postazione avanzata" di fronte a nuovi scenari dell’immigrazione, molto diversi da quelli passati.
h) Anche alla luce di ciò occorre, e su questo l’insieme dei dossier concorda particolarmente, ripensare velocemente all’assetto istituzionale che l’Italia deve darsi per gestire meglio le trasformazioni e le diverse sfaccettature dell’immigrazione, a partire dal nesso fra politica interna (della sicurezza e dell’inserimento sociale) e politica estera (della cooperazione e della "manutenzione" degli equilibri di pace).
In Italia troppa confusione vige ancora nella definizione delle responsabilità ai diversi livelli di Governo. Troppi Ministeri si affiancano e sovrappongono. La rete e le funzioni del Ministero Affari Esteri vanno integrate nel sistema e nella gestione della politica "interna"; il rapporto con i soggetti privati (sindacati, imprenditori, volontariato) va gestito in maniera chiara sul piano delle responsabilità; i diversi programmi di intervento (locali e nazionali, pubblici e privati) vanno coordinati tra loro. Occorre definire riferimenti istituzionali puntuali e omogenei, benché disarticolati ai diversi livelli territoriali. Varie proposte sono state avanzate, all’interno dei dossier e a margine, nell’auspicio che proprio le attività promosse dall’Agenzia possano dare impulso a una concreta riflessione su un migliore assetto istituzionale.
Appare necessario garantire una funzione di autorevole coordinamento delle varie competenze ministeriali, da precisare attraverso specifiche Direzioni, ed esiste la sentita esigenza di prevedere un ruolo di coordinamento che non sia solo "orizzontale" ma anche "verticale" per un raccordo e coordinamento col territorio, protagonista nell’effettiva gestione degli interventi. Ulteriore attenzione andrà posta alla sempre più auspicabile distinzione fra una "politica dei flussi immigratori" e una "politica delle minoranze".
Esistono quindi obiettivi ad alto provente di condivisione: la convergenza delle politiche nazionali sull’immigrazione in un’unica politica europea; la doppia vocazione dell’Europa e dei paesi di accoglienza di un’esigenza funzional-utilitarista da un lato e solidaristico-umanitaria dall’altro; la ormai evidente commistione fra politiche di immigrazione e strategie di cooperazione internazionale e di gestione/manutenzione dell'equilibrio mondiale; la volontà di promuovere la regolarizzazione e l'emersione dei fenomeni di immigrazione irregolare attraverso una doppia politica di inclusione dei "regolarizzabili" e di effettiva espulsione dei non ammissibili; il coordinamento delle politiche nazionali e locali.
Un nucleo di questioni emerge invece dai dossier come controverso e problematico, o perché le opinioni al riguardo variano da un autore all’altro, o perché direttamente proposto in termini problematici e aperti. Ed è il nucleo relativo agli assetti che più da vicino toccano nel vivo i nodi irrisolti dello sviluppo e del benessere nelle società occidentali avanzate.
a) Benché sia l’Europa che l’Italia si siano mosse nella direzione dell’apertura ai flussi di immigrazione, forti restano i dubbi sui criteri di priorità e di filtro che si intende applicare. Ad esempio, la programmazione dei flussi che avviene su base quantitativa, dovrà avvenire anche su base qualitativa, in funzione delle capacità di integrazione della società di accoglienza, delle esigenze del mercato del lavoro, dell’età e della qualificazione. Oppure, il controllo dei flussi regolari e irregolari, che andrà fondato su un modello di integrazione europea che è ancora lontano dall’essere condiviso e da cui dipenderanno più omogenei sistemi di concessione dei visti e di controllo degli ingressi (oggi solo parzialmente attivati). O promuovere una maggiore efficienza dei controlli delle frontiere, anche con interventi svolti in collaborazione con le autorità dei paesi stranieri.
b) Ancora: che tono e che peso dare alla solidarietà umanitaria? L'Italia fa molti sforzi per rimanere fedele a una sua consuetudine di flessibilità riguardo agli aspetti umanitari, e molti problemi insorgono con gli Stati vicini, come la Francia, l’Austria o la Germania, quando questo stile di Governo non é sufficientemente definito e garantito da norme e procedure che risultino in linea con la prassi dell’Europa continentale. Sarebbe superficiale imputarne la responsabilità al solito ritardo italico, attraverso cui sia il legislatore sia il funzionario italiano svolgono la propria pubblica funzione. La verità è che l’Europa non rappresenta un fronte unico, a dispetto delle convenzioni internazionali, e mostra uno scarto fra un’Europa "formale" e un’Europa "reale".
c) Le vere piste attraverso cui gli Stati Membri praticano e perseguono l'integrazione dei propri immigrati vedono all’interno di ciascun paese un intricato reticolo di esperienze e sperimentazioni, a volte contradditorie tra loro.
Dai dossier emergono varie accezioni di "integrazione", ciascuna delle quali sposta l’attenzione su diversi processi, enfatizzandone ora l’uno ora l’altro aspetto. Ad esempio, si distingue un'integrazione "sistemica" da una integrazione "sociale"; una "economica" da una "politica"; si tende a contrapporre l’integrazione alla "esclusione", all’"emarginazione" o viceversa all’"assorbimento"; ora si fa coincidere con "l’adattamento", ora da questo recisamente si discosta; la si fa correre parallela ora a concetti quali l’"acculturazione", l’"inserimento", la "partecipazione", l’"assimilazione", ora a concetti di segno opposto, quali il "multiculturalismo" e l’"interculturalismo"; la si rappresenta come un processo finalizzato alla costruzione di una comunità politica o come una tendenza fortemente democratica preoccupata soprattutto del rispetto delle differenze, di cui le minoranze sono un'evidente espressione.
Dubbi e arbitrarietà queste, sempre meno ammissibili, soprattutto in Italia, perché nocivi per la composizione di un consenso funzionale e di una diffusa e trasversale sensibilizzazione pubblica e istituzionale di fronte al concreto attuarsi delle procedure.
d) Ogni fenomeno migratorio, d’altra parte, come dicevamo, é un fatto sociale totale, e costringe a ragionare al di là di sé, sull’Europa, sui possibili scenari futuri. Così le riflessioni sull’integrazione portano a scuotere alle fondamenta il concetto stesso di cittadinanza, come le moderne Carte costituzionali delle nazioni d’Europa hanno fin qui concepito. Non si tratta, allora, di discutere il ruolo dei "nuovi cittadini" in uno spazio europeo, che deve limitarsi ad accoglierli, ma di affrontare l’esplodere del concetto stesso di cittadinanza; il traballare di quello di sovranità statale, a fronte di una sovranità europea; la progressiva legittimazione dei modelli di gestione federalista del territorio e l’incrinarsi del concetto di identità nazionale; il tutto verso nuovi, incerti, affascinanti e un po' inquietanti scenari, in parte di sapore antico e di precedente memoria, fra modelli pre-statuali da un lato ed egemonia delle sovranità cittadine dall'altro.
e) I flussi migratori dei primi dieci anni del 2000 in Europa richiameranno con sempre maggiore drammaticità l’attenzione generale sul tema della democrazia e dei rapporti tra maggioranze e minoranze, tra territori, tra economie e tra culture. Né si può dare per scontato che il concetto di democrazia applicato fino a oggi agli stati nazionali dell’800 e del ‘900 possa valere in un’Europa unita e all’interno di un mondo globalizzato. La convivenza collettiva si è sviluppata nell’epoca moderna nel nostro continente attorno ad alcuni paradigmi-chiave di declinazione del principio della democrazia: l’autodeterminazione, soprattutto nella fase degli irredentismi e della formazione degli stati nazionali; l’uguaglianza, soprattutto nella fase della industrializzazione; e l’inclusione, nella più recente fase degli stati del benessere. Nel nuovo ciclo di sviluppo socio-economico da qui a dieci anni l’Europa dovrà rivedere il proprio approccio a tutti e tre i paradigmi, alla luce dei problemi posti dai flussi migratori.
f) Anche la questione della cittadinanza dovrà essere rivista, pertanto, in considerazione del nuovo contesto di globalizzazione e di melting pot. Perderanno di importanza le frontiere geografiche tra nazioni, la famiglia di origine o l’etnicità, e si delineeranno le caratteristiche di una nuova cittadinanza, che avrà a che fare piuttosto con la residenza di elezione, con la collocazione lavorativa, con l’integrazione sociale, con l’appartenenza europea e con la pluriappartenenza.
g) Si è ormai definitivamente riconosciuta la strutturalità dell’immigrazione, ma non si è ancora, in Italia e in Europa, sufficientemente esplicitato il patto sociale fra immigrato e società di accoglienza, fra diritti e doveri reciproci, né esiste un pensiero unico sui modi attraverso cui i diritti politici possano essere acquisiti dalla popolazione immigrata, così come dalle varie minoranze etniche presenti in Europa e destinate a un ruolo sempre più importante, in termini demografici, economici, sociali e in rapporto all’evoluzione dell’identità europea, della capacità negoziale, fra reciproche "ansietà culturali" ed emergere di nuove opportunità.
Il documento che segue non rappresenta una sintesi in senso proprio dei ventidue dossier prodotti dall’Agenzia per il Giubileo nel corso dell’anno giubilare. Rappresenta piuttosto un tentativo di analisi che, prendendo spunto dai dossier e facendovi diffuso riferimento, ne propone una prima organica lettura, a fronte di tanti altri percorsi e spunti di riflessione che le attività di studio, i convegni, i seminari sul tema, previsti fra le attività giubilari, sapranno certamente suggerire.
La complessità della materia, la densità e la mole dei contributi realizzati, i percorsi spesso specialistici e talvolta distanti l’uno dall’altro, hanno impegnato il Censis nel tentativo di ricostruire l’organicità della ricca proposta dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo sul tema delle migrazioni, verso un comune fine, quello di produrre un pensiero più avanzato e linee di strategia adeguate alla sfida su uno dei più cruciali fenomeni della nostra epoca.
le migrazioni nel quadro globale
1. I grandi spostamenti di popolazione e le nuove linee evolutive
Da sempre i movimenti di popolazione hanno influito sui processi e sugli equilibri economici, storici e sociali dei paesi di ogni parte del mondo. Anzi, in una prospettiva squisitamente storica, sono proprio gli aspetti geografici e geopolitici a rappresentare le "variabili intervenienti" per l’evolversi di culture e civiltà, attraverso gli "usi" del territorio, più o meno stanziali e più o meno esclusivi.
Ciascuno può trovare propri esempi a conferma di un assunto, in verità piuttosto banale, che vede nelle migrazioni, e non nonostante esse, l’ingrediente principale dell’evolversi delle civiltà e perfino del costituirsi della stessa identità dei popoli, così come ciascuno può misurare, per proprio conto e secondo la propria sensibilità, quanto i territori, invasi, conquistati, occupati, "scoperti", o semplicemente percorsi, abbiano influito, attraverso le epoche, a forgiare le identità dei popoli, in un continuo movimento e in una perenne promiscuità.
Oggi, e al di là dell’approccio diacronico, non rischiamo dunque di contraddirci se consideriamo il fenomeno migratorio come un potente fattore di trasformazione sociale, economica e culturale.
Più che un problema o un fastidio, o un ostacolo al continuo processo di manutenzione delle varie identità collettive, le migrazioni ne costituiscono viceversa elemento di rafforzamento e forniscono la materia prima al necessario rinnovamento dell’identità collettiva stessa, che consiste proprio in un continuo processo di ridefinizione.
Ecco perché una qualsiasi analisi delle prospettive di sviluppo del processo migratorio nel nuovo millennio non può occuparsi di migrazioni tout court, e non può prescindere da un’attenta osservazione del più ampio scenario che chiude il secolo e, in particolare, degli effetti e delle cause esogene al fenomeno migratorio in senso stretto e che ne determinano i caratteri e le tendenze.
Impossibile sarebbe essere esaustivi in questo senso e in questa sede, giacché le particolarità dei vari "vissuti" nazionali e territoriali si presentano troppo dense di concause storiche per azzardarne anche solo una sintesi, del resto non tentata da nessuno dei dossier di riferimento.
Possibile risulta invece proporre in questa sede una possibile descrizione dei caratteri e delle tendenze del fenomeno migratorio moderno all’interno di un quadro concettuale, che sia in grado di stimolare riflessioni, che troveranno maggiore rispondenza all’interno di altre parti, sulla dimensione europea (parte II) e italiana (parte III).
Un tentativo in tal senso può essere condotto, attraverso l’approfondimento dei tre momenti, che non hanno la pretesa di essere esaustivi, lungo i quali si possono descrivere i processi migratori, nella loro configurazione più generale:
- le cause delle migrazioni, ovvero i fattori responsabili dell’origine del fenomeno;
- le tipologie delle migrazioni, ovvero le caratteristiche più diffuse e che meglio rappresentano il fenomeno nella sua attuale configurazione;
- le prospettive e le tendenze delle migrazioni, ovvero la direzione verso cui queste sembrano evolvere.
Si parla di cause, ma si dovrebbe - più convenientemente - parlare di concause o, con un termine più "morbido", di determinanti del fenomeno migratorio. È infatti un insieme di fattori che concorre alla nascita di progetti migratori, sia a livello micro, quello personale-familiare, sia a livello macro, quello delle correnti migratorie che coinvolgono masse di popolazioni da un paese a un altro, da un continente all’altro.
Le ragioni di ordine economico o politico-sociale sono i più comuni fattori di attrazione (pull factors) e di spinta (push factors) dei movimenti migratori: tra di essi la domanda/offerta di lavoro è uno dei principali. Essa si pone a cavallo tra la categoria delle migrazioni per ragioni economiche e quella delle scelte politiche: rappresenta in ogni caso una delle cause principali, al punto che, in molte legislazioni nazionali, il confine tra il termine "lavoratore straniero" a quello di "migrante" diventa molto labile.
La ricerca di lavoro tuttavia nasconde un cumulo di istanze intimamente connesse fra loro, e che concorrono a definire il complesso delle aspirazioni individuali e collettive delle popolazioni migranti.
Accesso alle risorse, benessere, livelli di vivibilità soddisfacenti, rappresentano fattori di spinta verso una emigrazione che trova sempre meno sostegno all’interno di un quadro oggettivo di standard di benessere, ma che sempre più si coniuga con variabili storico-culturali, rispetto alle quali i processi di globalizzazione fanno spesso da forza antagonista, innescando tendenze all’equilibrio di mutevole forma.
Il complesso delle cause si configura quindi come un fenomeno denso e spesso inestricabile, tra cui è tuttavia possibile riconoscere:
- determinanti economiche e socio- economiche;
- determinanti demografiche e politico- sociali;
- determinanti politiche e condizioni di persecuzione e conflitto bellico;
- determinanti ambientali e naturali;
- determinanti connesse al fenomeno della globalizzazione.
Per il carattere predominante che l’economia degli scambi riveste nel contesto dello sviluppo dei popoli, le determinanti economiche e socio- economiche rappresentano la categoria più estesa e più onnicomprensiva.
All’interno di questa, i più comuni fattori di attrazione e di spinta sono rappresentati dal differenziale esistente nelle risorse e nel tenore di vita tra i paesi di emigrazione e quelli di immigrazione, dalla condizione di sperequazione delle risorse e dalla povertà e precarietà strutturale di alcuni paesi specialmente del sud del mondo.
La categoria comprende aspetti salariali ma anche aspetti più generali, legati alle condizioni e alla speranza di vita, alle condizioni di alimentazione e di salute, alla disponibilità/indisponibilità dei beni di consumo o al costo della vita.
L’espansione demografica nei paesi del sud del mondo e il suo legame con le condizioni del mercato del lavoro sono altre importanti cause di un rilevante effetto di spinta verso l’emigrazione. Quanto "maggiore è lo squilibrio tra crescita demografica ed economica di un paese e quella di un altro paese tanto maggiore sarà la pressione migratoria che si verrà a creare tra i due paesi".
Tra le condizioni politico-sociali si devono considerare non soltanto la disoccupazione e le tensioni sociali determinate dalla condizione del mercato del lavoro, ma anche la carenza nell’offerta di servizi pubblici, di assistenza sanitaria e sociale e di accesso all’istruzione. Non ultimo, va considerato che alcuni governi locali mettono in atto vere e proprie politiche di incentivazione per favorire il ricorso all’emigrazione, derivandone vantaggi per la notevole incidenza delle rimesse degli emigranti sul PIL e, per i programmi di migrazione a termine, per il ritorno che questi offrono in termini di cultura, formazione e competenze.
c) Determinanti politiche e condizioni di persecuzione e conflitto bellico
Le determinanti politiche sono alla base di una condizione migratoria del tutto particolare, caratterizzata da uno scarso grado di progettualità migratoria e rientrante nei caratteri della vera e propria fuga dal proprio paese. Si tratta, in particolare, dei casi in cui regimi non democratici perpetrano sistematiche violazioni delle libertà fondamentali e delle minoranze o dell’esercizio della libertà religiosa e politica o in cui si verificano guerre o gravi disordini politici. Si va in questo caso dal limite minimo della persecuzione personale o sociale, e della migrazione per ricerca di asilo e rifugio in stati vicini, al limite estremo del conflitto bellico e delle lotte intestine, sempre più spesso su base etnica e razziale, che giustificano lo spostamento di grandi masse di persone e lo sviluppo, più o meno improvviso, di forti pressioni migratorie e di flussi di profughi in cerca di asilo.
I flussi migratori sono generati anche dal verificarsi di disastrosi eventi naturali, quali inondazioni e alluvioni, siccità e desertificazione, terremoti e inondazioni. Non sempre lo spostamento di popolazioni per ragioni di questo tipo è di breve periodo, anzi è frequente il caso di una stabilizzazione all’estero di questo genere di migranti. Questo aspetto inoltre tende a legarsi con altre motivazioni politiche o socio-economiche, come nel caso dei paesi dell’Africa sub-sahariana, la cui pressione migratoria aumenta per il doppio effetto dell’incedere del processo di desertificazione e per l’aumento demografico. Il degrado ambientale e le sfavorevoli condizioni climatiche, anche quelle meno estreme, possono facilmente incidere sia sulle condizioni di lavoro (impoverimento dell’agricoltura) sia sulle condizioni di vita (carestie).
e) Determinanti connesse al fenomeno della globalizzazione economica e sociale
La globalizzazione, riassumendo in sé molteplici aspetti, resta un fenomeno altamente dibattuto e controverso.
Se, da un lato, essa concorre ad accelerare e ampliare i flussi migratori preesistenti, allargando le possibilità di accesso di sempre maggiori porzioni di popolazione, dall’altro essa sembra incidere negativamente sul sistema globale dell’economia, aumentando il differenziale di ricchezza tra paesi avanzati e paesi in via di sviluppo.
Dal punto di vista delle migrazioni, la globalizzazione economica tende a tracciare un solco tra due grandi tronconi:
- i lavoratori qualificati, che migrano verso le economie industrializzate, le aree di libero scambio e il settore della new economy;
- i lavoratori non qualificati, che trovano migliori opportunità occupazionali nei paesi di immigrazione.
Indubbiamente la globalizzazione economica ha incrementato il numero di paesi di provenienza e di approdo e modificato - tanto in traiettorie quanto in modalità e magnitudine - i percorsi delle principali direttrici delle migrazioni.
Persino un’analisi delle cause sommaria come quella proposta rende immediatamente percepibile che esiste un nesso fra le cause determinanti la mobilità e la possibile configurazione di modelli migratori.
Al di là delle cause che innescano i fenomeni migratori tuttavia, altri criteri possono essere utilizzati per descrivere il fenomeno, alla ricerca di indicatori, o perlomeno caratteristiche salienti, che permettano di articolarne le caratteristiche, come ad esempio:
- il criterio del livello di "necessità" correlato al progetto migratorio;
- lo status giuridico di ingresso e la permanenza nel paese di accoglienza;
- l’effettiva durata del soggiorno;
- il tipo di integrazione proposto dal paese di accoglienza.
Una prima distinzione, per la verità del tutto formale e teorica, può essere tracciata tra mobilità frutto di decisioni libere e mobilità frutto di decisioni imposte dalla situazione esterna. La differenza emerge netta ad esempio tra i richiedenti asilo e rifugiati e l’emigrazione legata a motivazioni economico-occupazionali.
Il sottile discrimine deriva proprio dalle cause alla base dello spostamento e dal fatto che la migrazione "per scelta" manifesta maggiore progettualità estranea invece ai flussi di profughi, in fuga da persecuzioni o conflitti, più o meno calcolati e calcolabili.
È pur vero che, recentemente, laddove la pressione esercitata da condizioni economiche svantaggiate è talmente forte da annullare la possibilità di scelta, si constata l’inadeguatezza di una distinzione fra migrazioni "scelte" e "imposte".
Anche la scelta, in conseguenza dei fenomeni di globalizzazione, risponde a logiche sempre più complesse, attingendo da contesti di riferimento (valoriali, esperienziali, culturali, ecc.) sempre più aperti alla contaminazione dall’esterno e caratterizzati dunque dalla disomogeneità.
Per queste ragioni e per il fatto che spesso i flussi di rifugiati tendono a calcare le direttrici della migrazione ordinaria e a inserirsi in essa, si sta diffondendo tra gli operatori di settore la definizione di "flussi misti".
I flussi di rifugiati, d’altra parte, cominciati nel corso del XX secolo, in concomitanza con lo sviluppo degli Stati nazionali, si sono particolarmente acuiti nell’ultimo decennio, per l’aumento del disordine geopolitico mondiale venutosi a creare in conseguenza del crollo dell’ordine bipolare (scheda 1).
|
Scheda 1 - La disciplina internazionale in materia di asilo e rifugiati politici
Convenzione di Ginevra (1951) e Protocollo di New York (1967) La condizione di rifugiato è regolata internazionalmente dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo del 1967, sottoscritti da 134 Stati, tra cui l’Italia. Essa sancisce non tanto il diritto di ottenere asilo, ma quello di cercare e godere di asilo: si occupa solo dell’incidenza dell’asilo nel rapporto tra gli Stati, mediante il divieto di espulsione e di respingimento del rifugiato verso il paese di persecuzione (principio di "non refoulement").
Chi è "rifugiato" secondo la Convenzione di Ginevra La Convenzione definisce rifugiato "chiunque (involontariamente, ndr) si trovi lontano dal proprio paese e non possa ritornarvi per il fondato timore di essere perseguitato per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche". È da considerare che il termine "rifugiato" non è privo di ambiguità e difficoltà interpretative. Infatti, a questa categoria si sovrappongono recentemente, confondendosi spesso con essa nei complicati tentativi di stima del fenomeno, la categoria dei richiedenti asilo e quella degli sfollati (internal displaced people). È controverso inoltre se lo status di rifugiato possa essere riconosciuto anche a coloro che fuggono da oppositori politici e persecuzioni di vario tipo, non governative.
Tendenze e prospettive del regime dei rifugiati Il sistema di protezione sta subendo, di recente, profondi cambiamenti. L’emergere e il diffondersi di micro conflitti che determinano sempre più intensi e frequenti spostamenti di masse di popolazioni in fuga da un paese all’altro, ha spinto molti Stati a preferire un’interpretazione restrittiva della definizione di rifugiato, ponendo con ciò una forte barriera agli ingressi. Due sono le direzioni verso cui la Comunità internazionale si sta dirigendo.
Le recenti esperienze, in Europa, di frequenti spostamenti di masse di popolazioni in fuga hanno inoltre determinato la necessità di un approccio comune, allo scopo di instaurare una condivisione di responsabilità nella gestione del fenomeno. L’accordo più rilevante in materia è la Convenzione di Dublino.
La Convenzione di Dublino (1990, entrata in vigore in Italia il 1° settembre 1997) La Convenzione insegue lo scopo di evitare le situazioni che sono state definite di "shopping dell’asilo" oppure dei "profughi in orbita", espressioni che indicano il vagare dei profughi da uno Stato all’altro alla ricerca del riconoscimento dello status di rifugiato. Essa determina lo Stato competente per l’esame della domanda di asilo attraverso la definizione di alcuni criteri condivisi dagli Stati membri. Sulla base di queste regole, è competente lo Stato:
Sulla complessa questione dei rifugiati, relativamente ai caratteri della convenzione di Ginevra, alle recenti tendenze interpretative degli Stati, alle prospettive del regime dei rifugiati, alla categoria degli sfollati cfr. Caggiano, Migrazioni e diritto internazionale, cap. 4, Rifugiati e protezione umanitaria. Relativamente ai dati statistici si riporta il dato offerto dalla Caritas di Roma nelle Anticipazioni del Dossier Statistico Immigrazione 2000 in Caritas di Roma, La dimensione quantitativa del fenomeno migratorio. Per ulteriori considerazioni critiche, cfr. Caritas Diocesana, L'immigrazione a Roma. L'esperienza della Caritas, cap. 1, Perché si immigra a Roma? |
Relativamente al criterio giuridico della legalità degli ingressi si distinguono le migrazioni legali da quelle illegali, o meglio le regolari dalle irregolari. Alla base delle decisioni di regolamentazione e selezione degli ingressi si trovano motivazioni di ordine economico (instabilità o ridimensionamento del mercato del lavoro) e di ordine politico (chiusura delle frontiere) conseguenti - almeno in teoria ed eccetto evidenti disfunzionalità - alla suddivisione dell’ordine statuale. Risvolto problematico degli ingressi illegali è lo sviluppo di forme sempre più organizzate di criminalità che, infiltrandosi nelle maglie del fenomeno, ne sfruttano illegalmente alcuni aspetti o addirittura tendono a gestirne la clandestinità. In questo modo, le organizzazioni malavitose sviluppano le proprie attività a fini di lucro, in particolare quelle che si legano più strettamente al bisogno di migrare, quali il traffico di persone.
Relativamente alla durata del soggiorno e alla reversibilità del progetto, si possono distinguere i flussi di lavoratori, caratterizzati e sostenuti da motivazioni occupazionali e soggetti alla reversibilità sia stagionale sia generazionale, dai flussi di ricongiungimento familiare, che manifestano la tendenza alla stanzializzazione nel paese ospitante. Dal 1973 cresce la stabilizzazione del fenomeno, da quando cioè la forte crisi petrolifera ed economica ha scosso gli equilibri geopolitici mondiali, determinando una politica delle "porte chiuse" nei confronti delle nuove migrazioni. Indice della tendenza al radicamento nel paese ospite è la presenza delle seconde e terze generazioni o la creazione di famiglie multietniche generate da matrimoni misti.
Cambiando il punto di osservazione, ovvero ponendosi dalla parte dei paesi di accoglienza, è possibile individuare diversi modelli culturali che si rispecchiano nelle politiche sociali di integrazione, relativamente all’incontro di due identità, quella nazionale-autoctona e quella dei migranti. Il concetto stesso di "integrazione" (e le politiche che da esso scaturiscono) non è univoco né omogeneo. Facilmente si riscontrano differenze e sfumature all’interno della stessa definizione, dovute, non solo all’evoluzione che il concetto ha subito nel corso del tempo, ma anche ai criteri sociali, spaziali e culturali di riferimento. Gli stessi dossier di lavoro qui riassunti ne sono una manifestazione tangibile (scheda 2).
|
Scheda 2 - Le dimensioni dell’integrazione Dai dossier emergono varie accezioni di "integrazione", ciascuna delle quali sposta l’attenzione su diversi processi enfatizzandone ora l’uno ora l’altro aspetto. Ad esempio, si distingue una integrazione "sistemica" da una "sociale", una "economica" da una "politica", si tende a contrapporre l’integrazione alla "esclusione", all’"emarginazione" o viceversa all’"assorbimento", la si fa coincidere con "l’adattamento" o da questo recisamente la si discosta, la si fa correre parallela ora a concetti quali quelli di "acculturazione", "inserimento", "partecipazione", "assimilazione", ora a concetti di verso opposto quali quelli di "multicultualismo" e "interculturalismo", la si rappresenta come un processo finalizzato alla costruzione di una comunità politica o come una tendenza democratica al rispetto delle differenze di cui le minoranze sono espressione. Il complesso di tali e tante definizioni di integrazione compone una nebulosa di non facile definizione, la cui indeterminatezza, sebbene abbia finora giovato al convergere di un consenso politico auspicabile (ad esempio in Italia), rischia di nuocere tanto al dibattito quanto all’effettivo concretizzarsi dell’azione e degli interventi. Da un’attenta lettura dei dossier, e da un loro confronto con altri lavori, e specialmente con il Primo rapporto sull’Integrazione degli immigrati in Italia (novembre 1999) della Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati, sono tre le direttrici (gli assi) che permettono di spiegare e organizzare l’insieme delle definizioni adottate:
|
|
I tre assi definiscono e descrivono uno spazio, lo "spazio dell’integrazione", all’interno del quale qualsiasi processo, azione o modello può trovare una propria collocazione. Ad esempio, una politica che ponga l’accento su una rigorosa pianificazione dei flussi di ingresso secondo le esigenze di collocazione lavorativa, all’interno di un già consolidato sistema produttivo, pratica una politica di integrazione spostata sul versante "economia" dell’asse X, sul versante "assimilazione" dell’asse Y e sul versante "governance" dell’asse Z. Viceversa, una politica educativa aperta anche verso gli irregolari e le loro peculiarità culturali pratica una strategia di integrazione collocata sui quadranti del "welfare" (asse X), del "pluriculturalismo" e, dell’"individuo" (asse Z). Le varie accezioni di integrazione si collocano pertanto all’interno di questo spazio, secondo le diverse influenze che i tre assi determinano. |
Al fine di ottenere un quadro prospettico quanto più possibile preciso e vicino al vero delle migrazioni nel nuovo millennio, occorre osservare con attenzione i caratteri e le tendenze più recenti che hanno segnato i movimenti migratori della fine del XX secolo. Alcuni elementi in tal senso traspaiono dall’analisi delle cause e delle tipologie delle migrazioni. Tuttavia un’attenta lettura di quanto tracciato porta a evidenziare i seguenti caratteri e tendenze più recenti:
- specializzazione delle catene migratorie;
- interdipendenza dei movimenti e delle barriere;
- accelerazione;
- femminilizzazione dei flussi e tendenza alla stanzializzazione;
- incremento dei rifugiati.
Lo sviluppo delle migrazioni attraverso il sistema a catena rimane un elemento costante del fenomeno. Con ciò si intende quel "susseguirsi di micro-processi migratori (interni a quelli più generali) composti da arrivi di nuovi gruppi di immigrati derivati (…) dai richiami che effettuano le prime generazioni di emigranti". Nel periodo più recente, si constata la crescente specializzazione delle catene migratorie per area geografica di destinazione e area occupazionale, e accanto a ciò anche l’evoluzione di fenomeni dai risvolti preoccupanti, rappresentati dal traffico di manodopera e dalla tratta di esseri umani a scopi economici e di sfruttamento della prostituzione, nei quali si riconoscono sovente i caratteri di un nuovo schiavismo.
b) Interdipendenza dei movimenti e delle barriere
La globalizzazione interseca e si sovrappone alle migrazioni in molti suoi aspetti, non solo nel momento della genesi, ma anche durante lo sviluppo e l’evoluzione, imprimendo loro un carattere del tutto particolare.
In particolare molti flussi sono svincolati da legami storici, politici e geografici con i paesi di destinazione, e traggono almeno parziale origine dalla rapidità dei trasporti e della accresciuta facilità delle comunicazioni e degli spostamenti. In un contesto globalizzato il fenomeno migratorio è in sostanza il risultato della stretta interdipendenza di scelte individuali e di macro decisioni, come è evidente ad esempio nelle aree di libero scambio.
Alla specializzazione delle catene migratorie si sovrappone una parallela e contemporanea accelerazione e un notevole allargamento del numero dei paesi di origine e di quelli di destinazione. Non solo quindi paesi tradizionalmente esportatori di manodopera diventano obiettivo di immigrazione e le catene migratorie, da familiari e informali, si professionalizzano.
Grazie alla crescente facilità di collegamento si ampliano i bacini di provenienza e grazie alla rapidità della comunicazione la trasmissione di informazioni che permette il generarsi di catene migratorie è accelerata in modo consistente. La condivisione delle informazioni facilita inoltre la conoscenza e la intelligibilità di culture e contesti lontani del pianeta.
d) Femminilizzazione dei flussi e tendenza alla stanzializzazione
La presenza delle donne rappresenta un fattore importante per le tendenze delle migrazioni. Infatti, laddove è l’uomo a intraprendere il progetto migratorio, l’arrivo della donna e l’avvenuto ricongiungimento rappresentano un indice di stabilizzazione. Si osserva un aumento della presenza femminile nei flussi migratori internazionali: dal 1965 al 1990 si constata, in particolare, l’incremento del fenomeno delle donne "pioniere" per la migrazione. Si pensi all’immigrazione filippina in Italia oppure alle migrazioni sud americane in Spagna. I ricongiungimenti comportano una crescente tendenza alla stanzializzazione dei flussi e il progressivo abbandono del concetto esclusivamente lavorista dell’emigrazione.
Gli Stati sono sempre più diffidenti nei confronti del sistema tradizionale del "Rifugio". Manifestano la tendenza a rimpatriare in fretta i rifugiati, e a restringere le possibilità di riconoscimento della condizione di rifugiato. Ciò comporta un sostanziale aumento delle barriere all’ingresso e procedure accelerate per il rimpatrio. Conseguenze di questa tendenza si manifestano in due aspetti: l’aumento delle forme di assistenza, peacekeeping e intervento in loco nei casi di conflitti, anche mediante l’intervento di forze di pace internazionali; nei casi in cui la situazione improvvisa e prorompente comporta il rapido afflusso di masse nei paesi circostanti il ricorso sempre più frequente a forme di protezione temporanea sulla base di considerazioni umanitarie.
2. La politica internazionale
Sono innanzi tutto le macrodinamiche registrate a livello dei grandi blocchi continentali (Asia, Americhe, Europa) a dare il senso della globalità di un fenomeno che sempre più esplicitamente suggerisce di ridisegnare la mappa degli equilibri geopolitici mondiali, tenendo conto dell’ormai strutturale dislocamento di crescenti porzioni di popolazione.
Eppure, la crescente mobilità che mette in stretta connessione realtà geografiche e politiche un tempo percepite come distanti, e persino l’inarrestabile globalizzazione delle economie, dimostrano ancora di incontrare delle resistenze. Un esempio per tutti: la crisi finanziaria dei mercati asiatici non ha prodotto, come ci si sarebbe potuti aspettare, marcate tendenze migratorie in direzione est/ovest, ma i fenomeni di aggiustamento e riequilibratura di quelle economie sono rimasti, dal punto di vista delle migrazioni, circoscritti alle regioni interessate.
Su un altro versante, le profonde disparità dei sistemi socioeconomici delle due Americhe continuano a impegnare il Messico in un difficile lavoro di mediazione fra sud e nord, e lasciano intravedere la nascita di nuovi modelli di economia integrata, che proprio sui gap transfrontalieri basano la loro premessa.
A nord della grande fucina statunitense, con la sua tradizione regolamentarista, la solida economia canadese sperimenta con successo nuove aperture per flussi immigratori a termine, finalizzati a incontrare la propria domanda di manodopera.
La risposta a tale complessità ormai fisiologica dei flussi migratori non può non provenire da un contesto internazionale che sappia affrontarla su un unico piano di discussione. Eppure, la comunità internazionale ha ancora davanti a sé un notevole cammino prima di giungere a una risposta concordata e armonizzata, mentre l’internazionalizzazione del fenomeno migratorio risulta sotto molti aspetti un processo più maturo.
In particolare, la legittimazione di alcuni organismi internazionali, primariamente le Nazioni Unite, a opera dei diversi paesi, non risulta ancora un percorso compiuto, e gli stessi meccanismi di gestione di tali organismi necessitano di delicate interventi di messa a punto.
Alcuni fatti, tuttavia, sembrano suggerire composite strategie di risposta alle istanze sollevate dalle migrazioni nelle loro nuove forme. Il complesso delle riflessioni condotte sembra insistere soprattutto su due fronti:
- l’esperienza delle aree di libero scambio in una prospettiva integrata di sviluppo sostenibile;
- la tortuosa evoluzione (ancora in corso) del concetto di cittadinanza.
2.1 La linea di approccio integrato: programmazione dei flussi e azione sulle cause
L’affermarsi di aree di libero scambio e di associazioni di Stati, finalizzate alla gestione in comune delle risorse, del commercio e delle relazioni economiche, si trova ormai a uno stadio di sviluppo avanzato in numerose aree del mondo. Si pensi non solo trattati delle Comunità europee, successivamente confluiti nel Trattato dell’Unione europea, ma anche ad altri accordi di carattere politico-commerciale, quali il Nafta tra gli USA, il Messico e il Canada nonché l’accordo per il Mercosur, zona di libero scambio in Sud America.
Lo sviluppo di questi accordi che, in quanto motori dell’economia e del lavoro, fungono da polo di attrazione per le correnti migratorie provenienti dai paesi più poveri circostanti, comporta necessariamente per gli Stati membri un confronto. Le linee strategiche individuate prevedono alcuni sbocchi classici:
- in una prospettiva di chiusura, il controllo comune delle frontiere e la gestione dei flussi in ingresso, a difesa e protezione della zona di libero scambio;
- in una prospettiva di apertura, l’intervento sulle cause della pressione migratoria, nella forma della cooperazione allo sviluppo e con lo scopo di stemperarne l’acutezza.
Il secondo aspetto è il più complesso, e trova al suo interno notevoli articolazioni e sviluppi. Esso comporta che le associazioni di Stati pervengano all’adozione di linee comuni in funzione di governance della pressione migratoria. Gli Stati infatti adottano strumenti di controllo della pressione migratoria alla fonte, non solo con l’obiettivo di un’equa distribuzione delle risorse, della composizione degli squilibri politici e dei conflitti etnici, della gestione dell’incremento demografico, ma anche con la consapevolezza che, per agire in senso globale sulla complessità del fenomeno, si debba cominciare dalle cause. Per operare su tale complessità di obiettivi, gli accordi possono contemplare due modalità:
- creazione e gestione a livello sovranazionale di relazioni commerciali privilegiate con gli Stati di emigrazione, affiancate da accordi per la gestione comune dei rientri. Affinché la cooperazione si riveli efficace occorre progressivamente abbandonare le iniziative bilaterali in favore di quelle caratterizzate dalla multilateralità e gestite in sede sopranazionale;
- gestione di programmi di cooperazione come passaggio necessario per evitare il collasso commerciale degli stati limitrofi alle zone di libero scambio e perché le relazioni con questi Stati siano comunque salvaguardate. In sostanza, si tratta di operare una sorta di controllo al rischio di una eccessiva chiusura verso l’esterno. Si possono osservare esempi di questo tipo nel partenariato euromediterraneo.
Gli orientamenti più recenti in questo ambito che emergono anche dalla Conferenza mondiale di Rio de Janeiro del 1993 e da quella del Cairo del 1994, indicano la linea di approccio dello sviluppo sostenibile.
I contenuti di questa linea, che consiste più che in una semplice forma di intervento, in un principio applicabile sia ai paesi ricchi sia ai paesi poveri, e non limitato alla sfera economica, comprendono tre dimensioni:
- una dimensione sociale, relativamente all’equità nella distribuzione dei redditi e dei beni;
- una dimensione economica, relativamente all’afflusso costante degli investimenti e all’efficiente allocazione e gestione delle risorse;
- una dimensione ecologica e di crescita sia culturale sia politica.
Le due forme di intervento dimostrano l’esigenza di un approccio multidimensionale da parte degli Stati di destinazione. Va crescendo la consapevolezza che si richiede un approccio integrato, che unisca sapientemente l’intervento all’interno del paese di destinazione (controllo alle frontiere, sicurezza e politica di integrazione), con l’elargizione di finanziamenti e di investimenti produttivi nei paesi in via di sviluppo.
Questo ultimo passo comporta peraltro la necessità di accettare almeno in via transitoria l’immigrazione da questi paesi al livello dei singoli Stati nazionali ma anche al livello di associazioni di Stati.
Il processo storico in corso comporta una rivisitazione del concetto stesso di Stato-nazione su base etnica. Il modello tradizionale di cittadinanza va incontro a crisi nel momento in cui si riconosce l’esistenza di un tertium genus, quello dello straniero residente, a metà strada tra il cittadino e lo straniero (colui che - per definizione - si riconosce come "altro dal cittadino").
Le fondamenta di questa suddivisione vengono a vacillare nel momento in cui una serie di diritti civili e politici, finora riservati, anzi esclusivamente legati alla cittadinanza, si spingono fino al confine della rappresentatività e della partecipazione (scheda 3).
Vero è che il concetto di cittadinanza può assumere diverse sfumature: dall’interpretazione secondo la quale la cittadinanza esprime il senso di appartenenza di un individuo alla comunità-Stato, a quella più tecnica, secondo la quale essa esprime il rapporto di fedeltà allo Stato, al quale è legata una serie di diritti e doveri nei confronti dello Stato (apparato e comunità) e il cui contenuto varia a seconda dell’ordinamento nazionale.
La presenza stanziale dello straniero all’interno di uno Stato nazionale mette in discussione l’assetto dei principi alla base del concetto tradizionale di cittadinanza e pone interrogativi sulla ricerca di un nuovo equilibrio tra i diritti della persona e i diritti del cittadino.
Il processo di riforma del diritto di cittadinanza, in corso in una consistente parte degli Stati coinvolti, dimostra che si stanno, di fatto, sviluppando forme intermedie di cittadinanza, basate sull’ampliamento della sfera dei diritti riconosciuti agli stranieri.
Il processo che lentamente sta portando molti Stati al riconoscimento del diritto di voto e ad altre forme di partecipazione politica degli stranieri ne rappresenta l’esempio più evidente.
|
Scheda 3 - La cittadinanza: tra diritto interno e diritto internazionale Il concetto di cittadinanza La cittadinanza indica ed evidenzia due linee di rapporto:
Nel diritto costituzionale la cittadinanza indica uno status al quale corrispondono diritti e doveri. Il contenuto di questi varia in relazione allo Stato e al suo ordinamento. Si può tuttavia tentare di descriverne il "contenuto minimo", che comprende: il diritto di libera circolazione nel territorio dello Stato; i diritti di partecipazione pubblica (elettorato attivo e passivo); il diritto alla protezione diplomatica; il diritto di accedere a cariche e uffici pubblici; alcuni diritti sociali (assistenza sociale, mantenimento ecc); il dovere di fedeltà e, infine, il dovere di prestazioni personali (difesa del paese) e patrimoniali (tasse e contributi). Il diritto internazionale, in linea di principio, non interferisce sulle scelte dei singoli Stati in materia di cittadinanza ma, inteso a regolare i rapporti tra gli Stati, interviene nella forma di trattati internazionali soltanto a regolare le questioni di sovrapposizione di ordinamenti. I principi di base della cittadinanza pertanto sono regolati solo ed esclusivamente dagli ordinamenti nazionali anche se, invero, è innegabile la tendenza storica ad ancorare i diritti di cittadinanza agli standard internazionali e universali dei diritti umani. La condizione di apolidìa Non esiste, al momento, un vero e proprio diritto alla cittadinanza nella protezione internazionale dei diritti. Tuttavia, numerose convenzioni tra Stati contemplano tale diritto, che col tempo potrebbe assumere valore di principio consuetudinario. La conseguenza più importante dell’apolidìa consiste nell’impossibilità di godere della protezione diplomatica di uno Stato, l’accesso alla quale è riservato ai cittadini. Criteri di attribuzione della cittadinanza Secondo una definizione astratta, i criteri prevalenti relativamente all’attribuzione della cittadinanza al momento della nascita contemplano le ipotesi di:
A questi si aggiungono altri criteri sussidiari:
L’attribuzione della cittadinanza in alcuni Stati del mondo In realtà, gli Stati presentano, il più delle volte, una legislazione che contempera un bilanciamento dei due sistemi di attribuzione della cittadinanza per nascita. La scelta dell’uno o dell’altro indica la concezione della cittadinanza nello Stato: etnica o elettiva. La prima sottolinea lo status di appartenenza alla medesima etnia; la seconda privilegia il momento dell’adesione volontaria a un patto sociale connesso con lo status di cittadino. Lo jus soli è dominante nel Regno Unito, nei Paesi Bassi, in Francia e in Belgio. Al compimento della maggiore età gli stranieri nati nel paese acquisiscono la cittadinanza. Lo jus sanguinis è dominante in Svezia e Svizzera: i figli di stranieri, anche se nati nel territorio nazionale, non possono acquisire la cittadinanza se non attraverso il procedimento di naturalizzazione. Allo stesso criterio si ispira la legislazione giapponese. Nei paesi africani, gli Stati di influenza francese generalmente adottano il principio dello jus sanguinis, mentre il criterio dello jus soli ispira i sistemi dei paesi di derivazione britannica. Nei paesi islamici, l’appartenenza storica a una comunità politica o religiosa ha ancora il suo peso ai fini dell’acquisizione della nazionalità. La doppia o plurima cittadinanza Per quanto esposto (in particolare, dovere di fedeltà e nel caso estremo, di difesa), dovrebbe essere scartata l’ipotesi di una cittadinanza doppia o plurima. Tuttavia, alcuni accordi internazionali regolano la materia in via convenzionale, pur cercando di scoraggiare o eliminare la cittadinanza plurima. Questa coesistenza, in linea di principio, potrebbe dar luogo a conflitti tra Stati oppure originare situazioni giuridicamente abnormi di persone soggette alla giurisdizione di Stati diversi e chiamate a adempiere a requisiti contraddittori (cd "conflitti positivi o negativi di cittadinanza"). Soltanto alcuni paesi di particolare tradizione immigratoria tollerano la conservazione della doppia cittadinanza (in modo particolare USA, Canada e Australia, ma anche Gran Bretagna e Francia). Al momento dell’acquisizione della nuova, solitamente, il richiedente deve rinunciare alla nazionalità di origine (ciò avviene con particolare rigore in Germania, Austria e Lussemburgo; la Svezia tollera in alcuni casi la compresenza di una nuova cittadinanza, mentre il Marocco e la Grecia non permettono che si rinunci alla cittadinanza di origine). Per ulteriori approfondimenti sul tema della cittadinanza, cfr. G. Caggiano, Migrazioni e diritto internazionale. |
1. Dall’Europa delle migrazioni all’Europa dell’integrazione: un processo per tappe
Il secolo appena volto al termine ha conosciuto, in Europa, diverse stagioni in tema di movimenti dei popoli. Lungo l’arco del secolo le modalità migratorie europee hanno compreso:
- flussi di migrazioni interne all’Europa, secondo un movimento verso i paesi del nord del continente, economicamente più floridi;
- flussi in partenza dal continente verso paesi più sviluppati transoceanici, particolarmente Stati Uniti e Canada;
- flussi di scambio con le colonie, che hanno stimolato lo sviluppo di particolari flussi in entrata e in uscita dal continente.
La stagione più recente che si caratterizza per tempi e ritmi sempre più rapidi, appartiene alla storia degli ultimi trent’anni. Nel momento in cui il vecchio continente si affaccia al nuovo secolo, dall’analisi degli aspetti più significativi di questi trenta anni si può provare a ricavare considerazioni utili per i prossimi venti.
Tre date, in questo arco di tempo, hanno lasciato un segno nell’evoluzione del fenomeno:
- il 1973, anno della crisi petrolifera in medio oriente;
- il 1989, anno simbolo della fine dell’ordine bipolare;
- il 1992, anno che, più di ogni altro, è assurto a simbolo dell’Europa unita.
Le tre tappe hanno determinato profondi cambiamenti, di riassetto politico oltre che storico, e si pongono a cavallo tra la conclusione del processo di ricostruzione post-bellica e l’era della globalizzazione.
1.1 1973: punto di svolta delle politiche migratorie in Europa
La guerra del Kippur, la crisi petrolifera e il periodo di recessione che ne segue sono alla base delle drastiche politiche messe in cantiere dagli Stati del nord Europa per interrompere i flussi migratori che, fino ad allora, i programmi di ripresa economica e di ricostruzione del dopoguerra avevano alimentato e incoraggiato, per le possibilità di impiego di manodopera.
È opinione largamente condivisa che il 1973 rappresenti il turning point delle politiche migratorie dei paesi dell’Europa nord-occidentale e l’inizio di un processo di "inversione di rotta". Anche i paesi che fino ad allora avevano manifestato una politica accogliente e aperta all’ingresso di lavoratori stranieri cambiano drasticamente direzione e reagiscono alla crisi economica con l’adozione sistematica di politiche migratorie restrittive e, in qualche caso, "oppressive". Le strategie adottate dai paesi d’Europa sono di vario tipo:
- in Germania, nel corso del 1973, si attua una vera e propria inversione di tendenza della politica migratoria, volta non soltanto a bloccare i nuovi ingressi ma tesa a incoraggiare il ritorno in patria degli emigrati già presenti nello Stato;
- la politica restrittiva della Svizzera (dal 1974), si basa piuttosto sulla riduzione delle concessioni di permessi di soggiorno;
- la Francia decide di sospendere temporaneamente l’afflusso di manodopera straniera e così fanno, in diversa misura, anche l’Olanda, il Regno Unito e la Danimarca.
La trasformazione radicale incide profondamente su alcune caratteristiche delle migrazioni: l’incessante pressione migratoria cerca e trova nuovi sbocchi, alternativi a quelli classici, ormai "vietati". Le conseguenze di questa inversione di tendenza si manifestano in forme diverse:
- si generano nuove correnti verso paesi tradizionalmente esportatori di manodopera;
- si sviluppano canali illegali di immigrazione clandestina, che si radicano soprattutto in contesti di prossimità geografica;
- aumentano i ricongiungimenti familiari, nella misura in cui il progetto migratorio di coloro che sono già emigrati si fa più stabile;
- aumentano i flussi di rifugiati e richiedenti asilo, vuoi per lo stretto rapporto tra la condizione economica e quella politica di alcuni paesi, vuoi per la persistente disponibilità all’asilo da parte di molti paesi europei.
Gli effetti indicati al primo punto sono particolarmente evidenti nei paesi del Mediterraneo e soprattutto in Italia, dove il raggiungimento di un certo livello di benessere economico e il diffuso miglioramento delle condizioni di vita portano alla inversione del saldo migratorio, prima verso l’equilibrio e poi verso il segno positivo.
Le politiche di stop attuate si rivelano dunque parziali e non sortiscono del tutto gli effetti desiderati, rischiando anzi di provocare una serie di effetti boomerang: piuttosto che interrompere i flussi ne spostano la direzione. Elemento di continuità rimane quello per cui l’Europa, per la sua stabilità politica e il livello di benessere ormai largamente diffuso e sempre più equamente distribuito anche tra gli Stati meridionali, rappresenta un polo di attrazione per i paesi della sponda Sud del bacino del Mediterraneo e dell’Est, nonché un motore sempre più attivo del mercato del lavoro, grazie anche alla crescita degli scambi economici e commerciali e al processo di unificazione della Comunità europea.
È da queste premesse e su queste basi che nascono e si sviluppano i caratteri dei movimenti migratori degli anni Ottanta. L’Europa tutta diventa in questi anni un "polo di attrazione obbligato", mèta sempre più frequente di progetti migratori a medio e lungo termine oppure semplicemente trampolino di lancio delle correnti migratorie verso destinazioni transoceaniche.
La cerchia dei paesi emissari si allarga notevolmente, fino a comprendere paesi che non hanno alcun legame storico con il continente. L’afflusso in Europa è anche slegato dall’offerta di lavoro e - soprattutto - dai permessi di ingresso, perché si sono ormai create solide catene immigratorie la cui scaturigine sta nella criticità delle condizioni socio-economiche dei paesi di origine.
Emerge e cresce la componente irregolare delle migrazioni, fino a rappresentare un difficile problema.
Aumentano gli ingressi per ricongiungimento familiare, causa ed effetto di una crescente stanzialità delle comunità immigrate nei diversi paesi.
Allo sviluppo di queste correnti contribuisce, non poco, il nascente fenomeno della globalizzazione economica e sociale, anche se la facilità dei collegamenti e delle comunicazioni offre spesso una rappresentazione mistificata e ingannevole del benessere dell’occidente. Rimane vero che nei paesi d’Europa si constata l’esistenza di un "bisogno strutturale" di lavoro immigrato, legato ai processi di terziarizzazione dell’economia, di urbanizzazione e di modernizzazione.
Il crollo del muro di Berlino del 1989, che segna simbolicamente la dissoluzione del blocco socialista e la fine dell’ordine bipolare mondiale si inserisce come elemento di fragore e momento di squilibrio nello scenario della fine degli anni Ottanta.
Questo evento, ma ancor più quello che esso rappresenta, con l’apertura delle porte dei paesi dell’Est verso l’Europa, fa temere un esodo incontrollato che poi, in realtà, non si verifica, almeno, secondo le allarmanti aspettative. Al contrario, i paesi dell’Est diventano a loro volta una delle aree di attrazione di flussi migratori di tipo particolare:
- flussi in transito verso mete più ambite e definitive in Europa e fuori di questa;
- flussi costituiti da persone altamente qualificate, per l’impianto e lo sviluppo di stabilimenti di produzione, incidendo così anche sulle relazioni commerciali e tecniche di entrata e uscita all’interno dei propri territori.
La lancetta del saldo migratorio di alcuni di questi paesi segna oggi addirittura il valore positivo.
Non è del tutto vero però che lo squilibrio dell’ordine internazionale bipolare e la pressione dei due blocchi venuta meno non abbiano portano conseguenze per i flussi e per la condizione dei migranti. Le principali conseguenze attengono alla crescita delle micro e macro tensioni che scoppiano a livello locale e globale:
- a livello locale, si osserva lo scoppio di un numero crescente di micro conflitti su base etnica o regionale, fino ad allora "tenuti in sordina" dall’ordine internazionale, il cui effetto è anche quello dell’aumento dei popoli in fuga dai conflitti etnici e dalle guerre civili, e dunque di rifugiati e richiedenti asilo in cerca di protezione temporanea; esempi tipici sono quelli della ex-Jugoslavia, di alcune regioni della disgregata Unione Sovietica e, infine, della regione del Kosovo;
- a livello globale, si constata il diffuso emergere di tensioni sociali, che generano manifestazioni xenofobe per la diffusa percezione che gli stranieri rappresentino un problema di ordine pubblico e una minaccia alla sicurezza. Le società occidentali riversano così le loro inquietudini sugli immigrati anche, talvolta, attraverso forme di politica xenofoba e razzista.
A un cambio di rotta delle politiche europee e al verificarsi di così importanti riassetti geopolitici, all’inizio degli anni Novanta l’Europa risponde con indiscussa vitalità attraverso concreti tentativi di riassetto e convergenza istituzionale.
Il 1992 è l’anno simbolo che dà l’avvio a una nuova fase della storia dell’Europa: il Trattato dell’Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio rappresenta infatti - nelle intenzioni degli Stati membri - un punto di svolta per il futuro dell’Europa unita.
L’Unione Europea rappresenta il punto di arrivo di un lungo processo di tensione verso l’integrazione economica degli Stati membri e il punto di partenza per una nuova forma di cooperazione politica, che completi la piena realizzazione delle quattro libertà di circolazione (merci, persone, servizi e capitali).
Dopo il 1992, il settore istituzionale a livello europeo dedicato alla gestione dell’immigrazione e dell’asilo assume la definizione di "Terzo pilastro", mentre parallelamente a esso un "Secondo pilastro" si occupa di sviluppare una politica estera e di sicurezza comune.
Nella struttura del Trattato di Maastricht, infatti, si suole riconoscere la forma di un tempio sorretto da tre pilastri, che rappresentano i tre fondamentali settori di intervento dell’Unione (le Comunità economiche, o Primo pilastro; la Politica estera e di sicurezza comune (PESC), Secondo pilastro; e, infine, la Giustizia e gli Affari interni (GAI), Terzo pilastro (Fig. 1).
Il Trattato di Maastricht, pur nella consapevolezza che l’unificazione comporti il rischio di creare una Fortezza Europa, ovvero uno spazio autarchico e chiuso verso l’esterno da un’unica frontiera, aderisce all’opzione definita Europa dei popoli, che pone l’accento sulla dimensione dell’incontro tra le culture d’Europa piuttosto che sulla sovrastruttura avviata a estromettere gli Stati nazionali.
Gli ostacoli che si frappongono alla creazione di una struttura federale (o federalistica) fanno sì che, dalla conferenza intergovernativa che prelude alla firma del Trattato, emerga una soluzione di compromesso. Il Trattato affianca così alcuni nuovi modi di procedere nella cooperazione internazionale al metodo comunitario consolidato.
Nella gestione dei temi del Secondo e del Terzo pilastro, infatti, le istituzioni europee giocano un ruolo di secondo piano rispetto a quello degli Stati e gli atti che vengono prodotti assumono valore di indirizzo senza capacità di vincolare gli Stati a un comportamento determinato. In questo senso la soluzione dei pilastri si trova a metà strada tra la cooperazione internazionale e quella comunitaria: essa, pur collocandosi all’interno del Trattato dell’Unione europea, non partecipa delle forme proprie della Comunità europea, che rimane entità separata e distinta (Tav. 1).
Fin dal complicato processo di nascita del Trattato, appare evidente che il limite di una gestione di tal genere deriva dal considerare il fenomeno come questione meramente di ordine pubblico e di sicurezza. Anche gli accordi Schengen, che - parallelamente al Terzo pilastro - sperimentano lo spazio di libera circolazione delle persone, mostra limiti analoghi.
In realtà, sia il sistema Schengen sia il Terzo pilastro che, per vie diverse, aspirano a realizzare uno spazio sociale e non più solo geografico, all’interno del quale siano garantite le quattro libertà dell’Europa unita, richiederebbero un "approfondimento" tale che la cooperazione interstatale da sola non può fornire. Un primo passo nella direzione dell’"approfondimento" della libertà di circolazione delle persone, anche se limitato, viene poi mosso dal trattato di Amsterdam del 1997 che, per creare uno "spazio di libertà, sicurezza e giustizia", pone le premesse perché progressivamente si possano gestire in comune quelle questioni che cinque anni prima avevano impedito il formarsi di una unione anche politica.
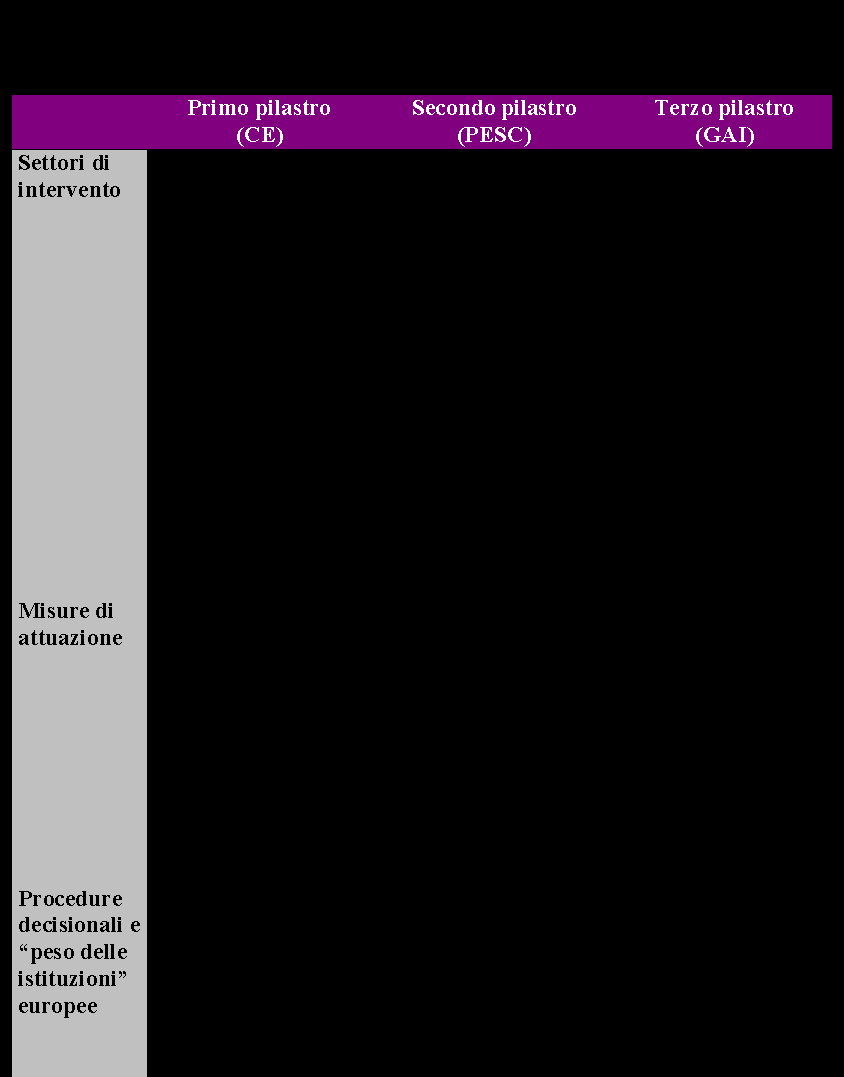 Tav.
1 - Il funzionamento dei "pilastri" dell’Unione Europea
(Trattato di Maastricht*)
Tav.
1 - Il funzionamento dei "pilastri" dell’Unione Europea
(Trattato di Maastricht*)
* N.B. Lo schema proposto si riferisce alle competenze e procedure definite dal Trattato di Maastricht. Il Trattato di Amsterdam (2 ott. 1997) ha modificato la struttura e il funzionamento dei pilastri. In particolare, esso ha trasferito alcune materie (tra cui: visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone) dal Terzo al Primo pilastro. Tale "trasferimento", tuttavia, non ha avuto per ora effetti immediati e segue un iter quinquennale, all’interno del quale le materie interessate vengono trasferite progressivamente all’organizzazione strutturale comunitaria.
Fonte: Fondazione Censis - Agenzia romana per la preparazione del Giubileo, 2000
2. La discontinuità
La fine dell’epoca coloniale e l’evoluzione successiva, con eventi di squilibrio dell’ordine geopolitico, recessioni economiche, alleanze economico-commerciali di rilievo e nuova globalizzazione economica e sociale, hanno contribuito in misura rilevante a cambiare la tipologia e le caratteristiche delle migrazioni: l’aumento degli ingressi di irregolari e clandestini o l’aumento di flussi di rifugiati sono soltanto alcuni degli effetti di tali "nuove" caratteristiche.
Relativamente alle politiche, per la verità, l’Europa, anziché fornire una risposta univoca o uniforme ai mutamenti in corso, ha reagito con modalità differenti. Si può affermare, con tutti i limiti di ogni generalizzazione, che si distinguono almeno due modelli principali di immigrazione e di integrazione, anche se rimane comune il contesto sociale post-fordista in cui la "nuova" immigrazione si inserisce:
- da una parte il modello dei paesi dell’Europa continentale (Francia, Benelux, Germania e, con sfumature particolari, Regno Unito), che vantano una tradizione migratoria consolidata;
- dall’altra il modello mediterraneo, proprio di Italia, Spagna, Grecia e Portogallo, tradizionali paesi di emigrazione, che hanno affrontato soltanto di recente il fenomeno opposto.
Nonostante una apparente frammentazione, dovuta ai percorsi storici che hanno segnato l’evoluzione dei modelli nei diversi paesi, il minimo comun denominatore delle caratteristiche dell’immigrazione nel nord Europa si articola in tre aspetti:
- "anzianità" del fenomeno; infatti, si considera comunemente che l’avvio del fenomeno migratorio nei paesi dell’Europa continentale possa essere collocato a partire dal XIX secolo, in corrispondenza con la diffusione del colonialismo, che per primo ha incoraggiato il trasferimento di lavoratori da e verso le colonie;
- continuità di rapporto con i paesi ex-coloniali: i flussi sono a tutt’oggi strettamente legati alla tradizione coloniale, per affinità culturale, come si può vedere nei flussi diretti in Gran Bretagna, provenienti da paesi del Commonwealth, o in quelli della Francia, provenienti dalle regioni del nord Africa (Algeria, Marocco e Tunisia) o, infine, nei flussi diretti in Belgio e nei Paesi Bassi provenienti dall’Africa centro meridionale e dall’America centrale;
- consolidamento sociale del fenomeno: la consistenza, anche statistica, dell’immigrazione ha formato col tempo, nei paesi dell’Europa continentale, un contesto sociale multietnico e multiculturale, da cui derivano politiche nettamente distinte per la gestione dei nuovi ingressi e per la gestione delle diversità etniche e delle collettività già sul posto, mentre le consolidate comunità di immigrati assumono ormai la dignità sociale e giuridica di minoranze etniche.
Sono almeno quattro le caratteristiche che differenziano i paesi mediterranei dal resto dei paesi dell’Unione:
- l’immigrazione come "effetto sorpresa", per il fatto che i paesi coinvolti sono stati quasi "colti alla sprovvista" dal cambio di tendenza e dal veloce e progressivo ingresso di immigrati;
- i particolari sbocchi occupazionali, non rappresentati dal tradizionale traino economico del comparto industriale, ma piuttosto forniti da altri settori, quali il lavoro agricolo stagionale, ambito che ha spesso avviato il primo dispiegarsi di molti progetti migratori, o il settore dei servizi alla persona (lavori domestici, assistenza agli anziani e ai bambini), che peraltro sopperisce a un sistema di welfare carente;
- le origini e la provenienza più eterogenee con popolazioni in fuga e alla ricerca di protezione, o connesse al paese di accoglienza da trascorsi storici e coloniali o attivate dal non sempre efficace funzionamento dei filtri e del controllo doganale e dalla debolezza tanto degli sbarramenti alle frontiere quanto degli strumenti legislativi e procedurali;
- paesi "a doppio senso", ovvero la persistenza, in qualche misura, della tradizionale connotazione emigratoria, attraverso il mai interrotto trasferimento di una porzione di emigrati autoctoni verso regioni settentrionali europee o oltreoceano e attraverso il mai reciso legame con filiere migratorie ancora vive e da più generazioni consolidate in più tradizionali paesi di immigrazione, in Europa e altrove.
La maggioranza dei flussi in ingresso nei paesi della sponda nord del bacino del Mediterraneo proviene da altri paesi del Mediterraneo. Riveste un ruolo molto importante pertanto il rapporto di prossimità geografica, sostenuto da fattori di vicinanza e affinità culturale e politico-sociale. Si vedano a proposito i flussi provenienti da alcune zone dei Balcani in Italia, la contiguità costituita dallo stretto di Gibilterra, o la "permeabilità" della Grecia alle pressioni immigratorie medio-orientali. Anche il partenariato euro-mediterraneo porta a tollerare, o meglio consentire transitoriamente, flussi migratori verso i mercati comunitari.
Adottando come variabili alcuni dati quali l’esposizione geografica e quella socio-demografica del paese di destinazione, il sostrato socio-economico e la capacità di assorbimento del mercato del lavoro, si possono tracciare alcune linee riassuntive atte a valutare in astratto e in senso comparativo le caratteristiche dei flussi e dei fattori di attrazione/accoglienza dei due modelli europei di immigrazione (Tav. 2).
Comparando gli impianti sociali di inserimento e i fattori, sia spontanei, sia giuridici, sia amministrativi, volti a consentire l’integrazione della popolazione immigrata, i paesi dell’Europa continentale hanno maturato un contesto sociale multietnico più stabile di quanto sia avvenuto nei paesi mediterranei. Viceversa, la tradizione migratoria meno consolidata dei paesi del Mediterraneo comincia a mostrare solo recentemente i segni della stabilizzazione e spesso le due dimensioni politiche, quella dell’accesso di stranieri e quella dell’integrazione di "nuovi cittadini" si confondono, persino a livello concettuale.
Tuttavia e indipendentemente dal modello migratorio, l’attuale tendenza promuove in ogni caso processi di rinnovamento delle legislazioni e delle prassi amministrative, sia in materia di immigrazione sia in materia di asilo: recenti novità si riscontrano sia in Germania, dove il fenomeno migratorio è più consolidato, sia in Italia e in Spagna, paesi dove si tende a ristabilire, attraverso le norme, un equilibrio tra le manifestazioni spontanee di assistenza e l’intervento pubblico.
Pertanto, i fattori geografici, sociali ed economici, che sono alla base dei progetti migratori e dei flussi di ingresso in Europa, incontrandosi con le scelte di politica di accoglienza e di integrazione adottate dagli Stati membri provocano il dispiegarsi di modalità ancora profondamente diverse di integrazione, tanto da far dubitare di una rapida convergenza di questi in un progetto comune.
Tav. 2 - I due modelli a confronto
|
Modello continentale
|
Modello mediterraneo |
|
Anzianità e continuità storica del fenomeno migratorio |
Brusco impatto di recenti e pronunciati fenomeni migratori |
|
Il passato di paesi coloniali determina la provenienza dei flussi |
La prossimità geografica determina la provenienza dei flussi |
|
Distinzione tra politiche di accesso e di integrazione |
Sovrapposizione tra politiche di accesso e di integrazione |
|
Inserimento degli immigrati nell’economia tradizionale (particolarmente, industria) |
Inserimento degli immigrati nel terzo settore (particolarmente, servizi alla persona) |
|
"Senso unico" delle migrazioni: netta connotazione in quanto contesti di destinazione |
"Doppio senso" delle migrazioni: persistenza di fenomeni di emigrazione |
|
Modalità di arrivo ormai consolidate: le filiere familiari (particolarmente, ricongiungimenti familiari) e le ex- colonie |
Sviluppo dei canali di ingresso clandestino e specializzazione di organizzazioni dedite al traffico di esseri umani |
|
Tradizionalmente paesi di destinazione |
Tradizionalmente paesi di transito e di frontiera |
|
Alta produzione legislativa (unico punto di convergenza dei due modelli) |
Alta produzione legislativa (unico punto di convergenza dei due modelli) |
Fonte: Censis - Agenzia romana per la preparazione del Giubileo, 2000
Il complesso delle analisi qui riassunte e contenute nei dossier esprime la consistenza di due modalità di interpretazione dell’immigrazione in Europa:
- una modalità prevalentemente sociale, che sottolinea il punto di vista della percezione collettiva del fenomeno dell’immigrazione;
- una modalità prevalentemente politico-istituzionale, che osserva il fenomeno dal punto di vista dello Stato, dunque valutandolo secondo il criterio della sovranità statuale.
Ambedue le modalità producono dubbi e perplessità. Sul primo dei due versanti l’immigrazione è spesso considerata una minaccia per l’identità collettiva, un problema per la sicurezza, per il welfare e per la congiuntura economica. Sul secondo dei versanti gli Stati europei appaiono percepire la cessione di segmenti di sovranità, quale è la gestione della politica dell’immigrazione, come una minaccia per l’identità statuale.
In entrambi i casi dunque, sia sul fronte sociale sia su quello politico-istituzionale, emerge la crucialità del tormentato processo di definizione o ridefinizione di una identità, nel primo caso identificata come "identità europea", e nel secondo caso, con una accezione politica, ma che ha in sé il germe per diventare tecnico-giuridica, come "cittadinanza europea". La forbice che distingue "cittadinanza" e "identità" sembra peraltro allargarsi sempre più. Tracciare i contorni della identità europea e della cittadinanza europea diventa d’altra parte fondamentale, nel momento in cui si riconosce che una parte dell’immigrazione condivide l’identità degli autoctoni pur non avendo ancora ottenuto i diritti di cittadinanza.
Sul versante dell’opinione pubblica e del diffuso sentire degli europei, l’immigrazione rappresenta una importante prova: nessuna politica di risposta può prescindere dai timori e dalla percezione che del fenomeno ha la società di accoglienza.
Al di là delle questioni che più direttamente riguardano gli immigrati in Europa, i loro diritti, le loro esigenze e aspettative, esiste una importante questione relativa all’impatto che il fenomeno determina sulla società di accoglienza.
I toni della percezione che in Europa si ha dell’immigrazione cambiano a seconda del paese rispondendo, in generale, alle seguenti tendenze:
- più di un quarto della popolazione in Europa percepisce il fenomeno con preoccupazione con paura, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza, più che i rischi per l’occupazione o, ancor meno, per l’identità;
- la quota di coloro che esprimono chiusura totale verso la concessione dei diritti è molto bassa, soprattutto per quanto riguarda i diritti sociali di base, ma anche per quel che concerne i diritti politici;
- le resistenze più forti verso gli immigrati si riscontrano in Italia, soprattutto sui temi della sicurezza, mentre una complessiva maggiore apertura è riscontrabile in Spagna, dove anche l’ipotesi di concessione dei diritti politici risulta maggiormente condivisa.
3.3 L’osservatorio politico-istituzionale
Le quattro libertà dell’Europa unita (libera circolazione di merci, persone, servizi, capitali), nonostante l’indirizzo offerto dal trattato di Maastricht, manifestano gradi di approfondimento assai diversi:
- il settore economico (CE, CECA, Euratom) ha intrapreso già da tempo la strada del metodo comunitario al quale si riconosce autonomia e indipendenza dai singoli Stati membri;
- la cooperazione del Terzo pilastro (Giustizia e Affari Interni) rimane, per quasi tutti i suoi aspetti, ancora aperta alle decisioni sovrane degli Stati membri, cui si affianca una nuova forma di "approccio intergovernativo istituzionalizzato".
In effetti, i due nuovi pilastri hanno incontrato, sia nelle negoziazioni del Trattato, sia nei tentativi di attuazione, forti resistenze da parte di alcuni Stati "euroscettici".
L’obiettivo di una unione sempre più stretta sembra incontrare ancora molti ostacoli, tra le preoccupazioni della perdita delle identità statuali e i rischi connessi alla creazione di una "Fortezza Europa". In cinque anni di operatività, il Terzo pilastro mostra limiti che si sostanziano principalmente in:
- complessità delle strutture ed eccessivo numero di sedi e livelli di negoziazione;
- mancanza di istanza democratica e controllo giurisdizionale, aggravata dalla mancanza di trasparenza di molte procedure;
- scarso rilievo giuridico e politico degli atti emanati, per via della profonda incertezza riguardo alla loro natura e al loro valore vincolante.
Rispetto al problema della individuazione di un sostrato di identità collettiva europea, emergono due obiettivi prioritari e paralleli:
- quello di una politica migratoria armonizzata tra gli Stati membri, che superi le soluzioni nazionali e nazionalistiche "che risultano per definizione repressive, difensive e sottosviluppate" e raggiunga un approccio quanto più possibile comune, anzi comunitario;
- quello di un inquadramento della questione migratoria di tipo integrato, che superi una visione dell’immigrazione esclusivamente legata alla questione della sicurezza e apra orizzonti politici e normativi multidimensionali ed evolutivi.
Le linee di intervento comune e coordinato dovrebbero affrontare tanto le cause, quanto la programmazione/gestione dei movimenti migratori in corso, quanto l’inserimento e l’integrazione nelle società di accoglienza.
Alcune delle conclusioni già anticipate trovano conferma nell’attuazione del sistema Schengen, attraverso il quale alcuni Stati membri hanno voluto sperimentare, negli anni Novanta, la dimensione della libera circolazione delle persone in uno spazio senza frontiere interne.
Il sistema presenta problemi analoghi a quelli del Terzo pilastro. Il parziale insuccesso dell’esperimento Schengen traspare non soltanto dalle prese di posizione della società civile (Ong, Chiese, gruppi di cittadini organizzati in reti transnazionali) ma anche e soprattutto dalle critiche del Parlamento europeo, della Commissione e della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
In particolare, il modello Schengen mostra contraddizioni e limiti proprio nella connessione con la questione della sicurezza. La libertà di circolazione risulta in tal modo claudicante.
Contraddizioni e i limiti derivano soprattutto da:
- la ricomparsa di controlli soppressi ufficialmente ai confini sotto forma di controlli occasionali, "a campione" o ad personam, con l’effetto della creazione di categorie di indesiderati, tra cui principalmente i sospetti criminali e gli stranieri;
- la segretezza, la mancanza di trasparenza, l’inaccessibilità dei procedimenti e delle strutture: buona parte dell’apparato del sistema Schengen, così come del Terzo pilastro, si è sviluppato in modo informale attraverso negoziazioni tra funzionari di polizia e dunque manca di trasparenza;
- la mancanza di controllo democratico e giurisdizionale, dato che nessun organo eletto partecipa al formarsi delle decisioni e nessuna Corte esercita un controllo preventivo o successivo sulle misure di attuazione.
3.5 Il Trattato di Amsterdam e la strategia del vertice di Tampere
Il Trattato di Amsterdam fornisce una prima risposta alle incertezze appena tracciate, muovendo verso il progressivo inserimento del Terzo pilastro e degli accordi di Schengen nella dimensione comunitaria.
Attraverso questo Trattato, gli Stati membri, avendo preso coscienza dei limiti della cooperazione in materia di immigrazione e asilo, hanno cominciato ad affrontare la questione della riforma delle strutture e dell’intero sistema di governo dell’immigrazione, decidendone il trasferimento dal Terzo al Primo pilastro.
La direzione della creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, basato su principi di trasparenza e controllo democratico e del riconoscimento che le questioni dell’immigrazione e dell’asilo non possono non convergere verso politiche comuni, viene ribadita con forza nel Vertice di Tampere.
Il Consiglio europeo svoltosi nella cittadina finlandese nell’ottobre ‘99 conferma e approfondisce l’indirizzo intrapreso, mediante una forte spinta nel senso di un approccio integrato e di una strategia comune degli Stati membri.
Le conclusioni della Presidenza del Consiglio del Vertice di Tampere mostrano i notevoli passi in avanti. In particolare il punto 3 chiarifica le contraddizioni, manifestatesi in tutta la loro problematicità nella realizzazione del sistema Schengen, quando afferma che esiste un legame imprescindibile tra libertà (di circolazione delle persone), sicurezza e giustizia e pur tuttavia questa "non dovrebbe (…) essere considerata appannaggio esclusivo dei cittadini dell’Unione", perché è contrario allo spirito e alla tradizione europea "negare tale libertà a coloro che sono stati legittimamente indotti dalle circostanze a cercare accesso nel nostro territorio".
L’invito è esplicitamente rivolto alla ricerca di "politiche comuni in materia di asilo e immigrazione", che si basino "su principi che siano chiari per i nostri cittadini e offrano allo stesso tempo garanzie per coloro che cercano protezione o accesso nell’Unione europea".
La strategia globale convenuta nel vertice di Tampere, e contenuta nel documento delle conclusioni della Presidenza, si dispiega su quattro aree di intervento ritenute fondamentali:
- partenariato con i paesi d’origine, nel senso di agire sulle cause del fenomeno e di abbattere la pressione migratoria;
- regime europeo comune in materia di asilo: ribadendo il rispetto assoluto del diritto di asilo, si auspica il ravvicinamento delle normative e delle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, nonché un accordo sulla protezione temporanea degli sfollati e sull’opportunità di mettere in comune riserve finanziarie da utilizzare nelle situazioni di afflusso massiccio di rifugiati;
- equità di trattamento per i cittadini di paesi terzi che soggiornano negli Stati membri, onde superare le imbarazzanti questioni emerse con l’applicazione della libera circolazione delle persone nel sistema Schengen;
- gestione dei flussi: si invita a considerare la necessità di una gestione più efficace con l’obiettivo di sradicare l’immigrazione illegale e contrastare il traffico, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento economico dei migranti.
Nella medesima ottica di approccio integrato, e soprattutto per gli aspetti che vincolano la libertà di circolazione al rispetto del principio della rule of law, si colloca la proposta di un organo preposto all’elaborazione di un progetto di Carta dei diritti fondamentali per l’Unione europea.
3.6 Prospettive
Se è vero che il riconoscimento di una disfunzione rappresenta il primo passo per superarla, il Trattato di Amsterdam, e soprattutto il Consiglio europeo di Tampere, per il fatto di aver colto la situazione di impasse createsi attorno al Terzo pilastro e al sistema Schengen, rappresentano decisamente un progresso.
La strada intrapresa sembra lasciare dietro di sé l’elemento di rischio dato dalla "Fortezza Europa", già paventata col Trattato di Maastricht: al contrario, sembra di poter dire che oggi l’Unione europea, nell’approccio multidimensionale che traspare dalle conclusioni del vertice di Tampere, abbia intrapreso la direzione dell’"Europa dei popoli".
Nel corso degli anni Novanta, la linea dell’approccio integrato è stata condivisa e adottata da una larga parte degli Stati europei. In particolare, ciò è evidente nelle numerose iniziative di cooperazione tecnica che gli Stati membri conducono con i paesi di emigrazione e nello sviluppo crescente di accordi internazionali detti "di riammissione".
Importanti segnali in tal senso provengono inoltre sia dai governi degli Stati membri, come dimostra, ad esempio l’elaborazione di un Documento strategico sull’immigrazione e la politica di asilo da parte della presidenza austriaca, presentato nell’estate 1998, sia dalle posizioni assunte dalla nuova Commissione presieduta da Romano Prodi, e in particolare da parte del commissario Vitorino.
Non è detto che la strada intrapresa non incontri ostacoli o vistose deviazioni, in modo particolare relativamente alla piena comunitarizzazione della materia migratoria. La flessibilità, contenuta nel Trattato di Amsterdam e che permette ad alcuni Stati membri di non partecipare a tutte le iniziative dell’Unione a seconda della loro valutazione tecnico-politica, rappresenta una fonte di rischio per il raggiungimento degli obiettivi comuni.
"Il pendolo può ancora oscillare, soprattutto a causa delle evoluzioni politiche in seno agli Stati membri. A un estremo si trovano le politiche decisamente restrittive degli ingressi e orientate sulle questioni di sicurezza (…) decise ad agire sulle cause del fenomeno migratorio nei paesi d’origine; all’altro estremo si trovano politiche ispirate dal principio della protezione dei diritti umani, decise a promuovere l’integrazione omogenea degli immigrati nelle società europee e a combattere discriminazioni, razzismo e xenofobia".
Punto di partenza, ampiamente condiviso dalle analisi contenute nei dossier proposti, consiste nel considerare l’immigrazione come un fenomeno strutturale al funzionamento della società italiana, sia in termini socioeconomici che in termini demografici.
Com’è noto, nel corso degli ultimi 20-30 anni, il saldo migratorio in Italia ha registrato un importante cambio di tendenza: al netto incremento di forza lavoro proveniente dall’estero si è andato accompagnando un vistoso decremento della tradizionale esportazione italiana di mano d’opera. L’Italia, da paese di emigrazione, si è così andata gradatamente trasformando in paese di immigrazione.
Di ciò tuttavia, almeno fino a tempi recenti, non sono state enfatizzate le caratteristiche funzionali allo sviluppo socioeconomico del paese, ma sono stati viceversa sottolineati gli aspetti più entropici e destabilizzanti, tanto nella comunicazione mediatica e nell’opinione pubblica, quanto nella coscienza politica, e perfino nella stessa produzione legislativa. Considerare, viceversa, l’immigrazione un fenomeno strutturale significa, fra l’altro, trattarlo come non più episodico o transitorio. E significa, inoltre, leggittimarne il ruolo di coagente e in parte di equalizzatore delle tensioni endogene al sistema stesso. Eppure, un fenomeno strutturale non è necessariamente strutturato: l’immigrazione in Italia si presenta, nella descrizione estrapolata dai lavori condotti, come un fenomeno altamente composito, polimorfo, policentrico e dinamico.
L'immigrazione in Italia è, innanzi tutto, in costante, rapida evoluzione. È andata crescendo, e ha conosciuto stagioni diverse.
La composizione è andata continuamente modificandosi, dando vita nel corso degli anni a diversi modelli di insediamento e di transito. Tutto ciò ha finito col tratteggiare uno scenario molto composito, all’interno del quale continuano a emergere sempre nuove tipologie mentre si consolidano quelle che, nel tempo, si sono già stabilmente impiantate nel paese.
Attualmente, mentre quasi la metà degli immigrati in Italia proviene da vari versanti del bacino del Mediterraneo (dal Maghreb, dai paesi dell'ex-Jugoslavia, dall'Albania, dall'Egitto e dal Libano) e da altre aree dell’Europa centro-orientale (ex Urss, Polonia, Rep. Ceca) un’altrettanto vasta porzione di presenze proviene da paesi più lontani, come le Filippine, il Sub-continente indiano, la Cina e il Senegal, oltre che da varie regioni del Sud America.
Questi brevi cenni ai paesi di provenienza lasciano trasparire il carattere altamente polimorfo e policentrico dell’immigrazione in Italia, uno degli aspetti più peculiari, al punto che si parla a proposito di "complesso arcipelago dell'immigrazione".
Al contrario di quanto verificatosi in paesi di più consolidata tradizione immigratoria, dal Regno Unito alla Francia, dove l‘immigrazione risulta strettamente connessa al trascorso storico-coloniale che ha progressivamente costruito fra nuovi arrivati e autoctoni una continuità (linguistica, storica, economica, culturale) di cui l’immigrazione rappresenta una specie di logica conseguenza, i flussi in Italia sono il prodotto di una più variegata gamma di cause e motivazioni, il cui effetto finale è l’eterogeneità, per quanto concerne le comunità etniche e nazionali rappresentate e in quanto ai diversi gradi di affinità o estraneità fra queste ultime e il nostro paese.
Anche la distribuzione delle singole comunità nazionali sul territorio varia in funzione dei modelli di insediamento territoriale:
- distribuzione territoriale più diffusa per marocchini e albanesi;
- distribuzione territoriale più concentrata e contenuta per i cittadini della ex Jugoslavia e per i tunisini;
- pronunciata concentrazione territoriale per filippini e cinesi.
L'immigrazione in Italia presenta inoltre peculiarità per quel che riguarda la composizione in base al genere. Diversamente dalla storia e dall'evoluzione delle grandi migrazioni intraeuropee, che hanno visto come protagonista la componente maschile, i flussi in Italia manifestano una tendenza singolare: a una sommaria osservazione la componente maschile e quella femminile risultano in sostanziale equilibrio; nel dettaglio si osserva che esiste una suddivisione per genere legata al paese di provenienza e alla cultura di appartenenza.
A collettività nazionali dove è predominante la presenza femminile (in prevalenza comunità cattoliche provenienti dall’America Latina, o dalle Isole di Capoverde e dalle Filippine) corrispondono altre collettività dove prevale il genere maschile (soprattutto le comunità di tradizione islamica, provenienti sia dal Nord Africa, sia da varie regioni asiatiche e medio orientali).
L’accentuata prevalenza femminile in Italia rispetto alla situazione di altri paesi si spiega anche in connessione alla domanda di lavoro, in gran parte proveniente dal settore dei servizi alla persona e della collaborazione familiare.
Il disequilibrio per genere risulta peraltro tipico del periodo iniziale dell’immigrazione, quale è quello che sta attraversando l’Italia. Col tempo, man mano che l’emigrazione si stanzializza, il disequilibrio tende a diminuire, soprattutto attraverso i canali del ricongiungimento familiare e dei matrimoni, benché per ora sporadici, soprattutto nella forma mista (la maggior parte di cui tra stranieri e italiani).
Riguardo ai modelli di stanzialità della popolazione immigrata, si osserva in Italia una vivace mobilità, con due macroscopiche tendenze:
- da un lato, le migrazioni stagionali di lavoratori, legate alla stagione agricola e alla domanda di braccianti nelle regioni del meridione durante le stagioni dei raccolti, con conseguente "rientro" nei restanti mesi invernali;
- dall’altro, un fenomeno che può assimilarsi a una migrazione nell'immigrazione, con i lavoratori immigrati nel Mezzogiorno che, una volta regolarizzata la propria posizione, si trasferiscono nelle regioni settentrionali, in Veneto o in Lombardia, alla ricerca di un più facile inserimento e secondo uno schema già sperimentato dai lavoratori italiani meridionali.
A questa relativa mobilità corrisponde una staticità generale della popolazione autoctona del nostro paese, con vischiosità occupazionale e complessiva scarsa propensione al trasferimento da una regione all’altra, soprattutto a causa dei vantaggi offerti dalle filiere informali di sostegno (economico, logistico, emotivo relazionale) che, a conti fatti, incoraggiano alla stanzialità.
Si intravede pertanto il possibile scenario di due Italie, l’una povera, mobile e multietnica, l’altra ricca, stanziale e "chiusa", anche se le mille variabili in gioco rendono incerta e imprevedibile la direzione (e la velocità) che il processo di integrazione potrà imboccare.
Con riguardo all'insediamento urbano o rurale dei migranti si registra la tendenza dei cittadini stranieri a preferire i maggiori contesti urbani. Numerosi sono i motivi che spiegano la concentrazione di immigrati nei comuni capoluogo. Fra questi:
- la crescente offerta di lavoro nel settore terziario, che attinge abbondantemente dal bacino di manodopera dei lavoratori immigrati;
- le concrete possibilità di coesione e incontro con il proprio gruppo etnico;
- la vicinanza e il contatto con le sedi amministrative e burocratiche italiane e quelle di rappresentanza del proprio paese.
Le esperienze di Roma e Milano e l'evoluzione della gestione dell’immigrazione in queste città rappresentano un importante esempio. Roma, in particolare, riassume in sé tutta l'ambivalenza, le contraddizioni e i contrasti dell’immigrazione in Italia, presentandosi come meta sia transitoria che di insediamento, tappa obbligata per attivare o completare formalità amministrative presso le Ambasciate e i Consolati, i Ministeri italiani e le organizzazioni internazionali, particolarmente evidente per i richiedenti asilo che, in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato, si fermano nella città per un periodo che sempre più spesso supera l’anno. Al contempo la città è prescelta da larga parte dell’immigrazione come sede stabile, anche perché vanta, grazie soprattutto al poderoso sostegno della Chiesa cattolica, un capillare sistema di accoglienza, sia in termini di servizi che in termini di strutture. In questo senso, per indicare il rapporto spesso rovesciato tra strutture di assistenza del volontariato sociale e strutture della pubblica amministrazione si è parlato di "paradosso romano".
Milano, con la sua cintura, rappresenta la realtà lombarda più recettiva. La condizione del capoluogo lombardo tuttavia differisce in modo sostanziale da quella di Roma, sia in termini di tessuto socio-economico di accoglienza e capacità di assorbimento del mercato del lavoro, sia in termini di approccio istituzionale e del privato sociale al fenomeno, sia dal punto di vista del progetto migratorio dei migranti che approdano alle due realtà. Nel capoluogo lombardo le motivazioni che attirano i flussi di immigrati sono prevalentemente di tipo lavorativo-occupazionale, legate ai settori dei lavori domestici, del commercio e dei servizi di ristorazione tipici della città, nonché, a quello industriale, localizzato principalmente nell’hinterland.
Dal punto di vista dei progetti migratori nelle due città, numerosi elementi indicano che l’orientamento degli immigrati a Milano tende in misura maggiore alla stabilizzazione sul territorio, mentre Roma si profila come un centro di transito.
Comunemente si afferma che l’Italia, da paese di transito, si è andata trasformando in paese di destinazione. Questa affermazione è in parte condivisibile, e peraltro supportata, oltre che dai dati statistici, da altre considerazioni.
Da un lato, infatti, lo sviluppo economico degli ultimi anni ha ridotto lo scarto fra l’Italia e gli altri paesi a economia avanzata, rendendo il contesto sempre più appetibile per flussi di migranti e propizio al loro inserimento socioeconomico.
Dall’altro, alla chiusura delle frontiere europee nel corso dell’ultimo ventennio non è corrisposta un’altrettanto efficace politica di chiusura delle frontiere italiane, col risultato di uno scarto fra accesso in Italia, più facile, e accesso in Europa, più impervio.
All’interno di questo quadro generale di riferimento i progetti migratori che interessano l’Italia, variano anche al variare delle possibilità di inserimento e delle chances di passaggio in altri paesi, quali la Francia o la Germania, di più consolidata tradizione di accoglienza. Per necessità o per convenienza, a seconda dei casi, gli immigrati tendono a stanzializzarsi in Italia, incrementando i ricongiungimenti familiari, con la maggiore equidistribuzione fra uomini e donne delle varie comunità etniche, e generazione di figli in Italia.
Sarebbe tuttavia superficiale far coincidere il modello di stanzializzazione in Italia con le esperienze che l’Europa continentale o il Regno Unito hanno sperimentato qualche decina di anni fa. Alcuni fenomeni infatti rendono il caso italiano notevolmente differente, in quanto:
- più di prima gli immigrati concepiscono il proprio progetto migratorio come un’esperienza a termine, anche grazie alle sempre più accessibili opportunità di spostamento rispetto al passato, fra paesi di origine e paesi di destinazione, che favoriscono una sorta di "pendolarismo globale";
- la stessa maggiore mobilità e ricchezza dei mezzi di trasporto e comunicazione rendono più facile lo spostamento verso altri paesi con buone opportunità di inserimento occupazionale (flessibile, stagionale, delocalizzato), favorendo una tendenza a un "nuovo nomadismo" già evidente per alcune nicchie occupazionali altamente specializzate.
Piuttosto le politiche di chiusura e controllo tendono a indurre stanzialità, facendola percepire come un’ardua conquista e inibendo i meccanismi di stagionalizzazione, flessibilità, mobilità e cooperazione economica con i paesi extraeuropei. Da paese di transito, e attraverso l’esperienza di paese di destinazione, l’Italia si trasforma così come il resto l’Europa, in un eterogeneo e composito bacino di opportunità, di cui né il solo transito né la semplice stanzializzazione sono espressione esauriente.
Sebbene più qualificate di quanto comunemente si creda, l’immigrazione in Italia non offre competenze tecniche e settoriali particolari. Per la combinazione di ragioni di sussistenza e di minore radicamento sul territorio, gli immigrati sono generalmente nella condizione di offrire, rispetto alla concorrenza autoctona, maggiore flessibilità, disponibilità a trasferimenti territoriali e maggiore adattabilità a lavori meno remunerativi per, per provvisorietà (lavori stagionali) o per la considerazione sociale (bassa manovalanza).
Non si deve sottovalutare inoltre che la condizione di irregolarità in cui si trova un discreto numero di immigrati è un comodo bacino di reclutamento di forza lavoro, a beneficio di tutto il settore dell’economia sommersa. È infatti evidente che le caratteristiche della clandestinità e del lavoro irregolare tendono a sposarsi felicemente. Anche se un dato offerto di recente dalla Commissione dimostra che le regolarizzazioni degli ultimi anni hanno provocato un aumento dell'occupazione legale immigrata (scheda 1).
|
Scheda 1 - Il Primo Rapporto sull’Integrazione degli immigrati in Italia Secondo il decreto legislativo 25 luglio 1998, n° 286 concernente il "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", art. 46 comma 2, la Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati "ha i compiti di predisporre per il Governo, anche ai fini dell’obbligo di riferire al Parlamento, il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l’integrazione degli immigrati". L’altro compito assegnato alla Commissione consiste nel rispondere a specifici quesiti posti dal Governo. I quesiti hanno fin qui riguardato l’opportunità di riformare la legge sulla cittadinanza in Italia, l’opportunità di presentare una legge ad hoc per popolazioni Rom e Sinti, nonché l’ideazione di strumento specifici di integrazione di queste minoranze, l’opportunità di estendere il voto locale agli immigrati. Su questo e altri temi la Commissione ha commissionato ricerche, organizzato convegni, pubblicato quaderni. Il primo Rapporto sull’Integrazione degli immigrati in Italia, del novembre 1999, si compone di una lunga introduzione e di otto capitoli, e si conclude con note informative che riguardano la ripartizione dei fondi, l’attività delle regioni, i compiti degli organi che osservano e indirizzano le politiche di integrazione, l’attività svolta dalla stessa Commissione per le politiche di integrazione degli immigrati. I capitoli approfondiscono l’analisi demografica e di alcuni settori in cui si realizza o non si realizza l’integrazione (lavoro e piccole imprese, istruzione, alloggio, salute, partecipazione politica, sicurezza e discriminazione). |
Il settore che sembra non conoscere segni di flessione per i lavoratori immigrati è invece quello del lavoro domestico, dei servizi alla persona e alle famiglie, come riflesso delle modificazioni del mercato occupazionale ma anche della progressiva senilizzazione della società italiana, sempre più agiata e bisognosa di assistenza.
Curiosamente, la distribuzione degli immigrati nelle regioni italiane non corrisponde alla mappa dell’offerta di lavoro: la presenza di lavoratori immigrati si riscontra sia nelle regioni centro settentrionali, caratterizzate da un basso tasso di disoccupazione e da una vivace domanda di lavoro, sia in quelle centro meridionali e insulari, caratterizzate da alti tassi di disoccupazione e da una strutturale debolezza dell'economia. La mappa dell'immigrazione in Italia sembra quindi comporsi indipendentemente e nonostante la saturazione del mercato del lavoro a seguito dell’effetto congiunto di altri fattori geografici e sociali .
a) Sud, immigrazione ed economia sommersa
Fenomeno tipicamente italiano è pertanto l’inserimento di filiere di immigrati all’interno di un’economia, quella meridionale, fortemente connotata da modalità informali, sommerse e talvolta illegali.
Immigrazione ed economia meridionale pertanto - dall’edilizia all’agricoltura, dall’indotto turistico al grande bacino dei vari servizi alla persona - si incontrano in una costellazione di situazioni lavorative in cui, all’adattabilità delle categorie meno protette (gli irregolari, i più poveri, i meno istruiti) corrisponde una offerta di impiego per mansioni poco specializzate e scarsamente remunerative, che la mano d’opera autoctona non è più disposta a svolgere.
Così si spiega l’apparente paradosso della coesistenza di una significativa presenza immigrata e della disoccupazione autoctona nelle regioni del sud. Altre caratteristiche socioambientali e socioculturali, connaturate al nostro meridione, concorrono a spiegare l’inserimento di immigrati anche nelle località meno sviluppate della penisola.
Come già avvenuto in altri paesi, anche in Italia tende a diventare peculiare il ruolo quasi oligopolistico che alcune nazionalità sono andate esercitando nel corso del tempo in alcune nicchie o comparti del mercato del lavoro: servizi di collaborazione domestica per le popolazioni di provenienza asiatica (Filippine, Sri Lanka, ecc.); varie forme di lavoro "duro" (conceria e macellazione, industria pesante) per popolazioni africane di area maghrebina o sub sahariana; agricoltura e ristorazione per le popolazione di provenienza sub-asiatica; edilizia per varie popolazioni provenienti dall’est europeo.
Il carattere di specificazione etnica di certe occupazioni è d’altronde anche alla base di nuove forme di imprese economiche gestite da immigrati: nei centri urbani cresce il numero dei ristoranti etnici, delle piccole botteghe e di altri esercizi commerciali, che fanno della cultura etnica il proprio punto di forza (il cosiddetto ethnic business). La funzione del credito svolge peraltro un ruolo determinante per lo sviluppo di iniziative di lavoro autonomo da parte degli immigrati (scheda 2.).
|
Scheda 2 - Gli immigrati e il credito I termini della questione La questione della esclusione finanziaria di alcuni soggetti definiti come "non bancabili" si presenta di scottante attualità particolarmente per la popolazione immigrata. Il miglioramento dei rapporti tra banca e immigrati consentirebbe, senza dubbio, un progresso per le condizioni di integrazione nelle società di accoglienza. La mancanza di fondi, infatti, è il maggior ostacolo all’attuazione di un progetto di piccolo investimento produttivo per gli immigrati, i quali - diversamente dagli autoctoni - non possono ricorrere, al contesto familiare, spesso assente, minimo oppure particolarmente indigente. I vantaggi di un nuovo sistema Sono state avanzate, in relazione a questa impasse, alcune proposte e sperimentazioni per il miglioramento dei rapporti tra banca e immigrati. I vantaggi di una attenta politica bancaria in direzione di forme di agevolazioni di credito per gli immigrati consentirebbero di agire su:
Il micro credito - Il caso della Grameen Bank Alcune esperienze di erogazione di credito sono state condotte sia in paesi in via di sviluppo (PVS) sia in paesi industrializzati. La concessione di micro- crediti erogati senza necessità di garanzie, basata sul principio del diritto al credito come diritto fondamentale, è alla base del caso della Grameen bank. Questa banca, fondata in Bangladesh nel 1976 e diffusasi poi nell’esperienza di altri paesi, si basa sui seguenti principi operativi:
Agli imprenditori viene erogato il prestito al ricorrere di alcune condizioni:
I risultati ottenuti sono decisamente positivi, se si considera che nel 98% dei casi si è raggiunto il rimborso alla scadenza dei prestiti e solo lo 0,5% del complesso di questi è andato a male. Esperienze di micro credito, con alcuni adattamenti degli obiettivi e delle modalità di funzionamento del sistema, sono state condotte anche in Usa, Canada ed Europa, ma non rivolte in modo particolare alla categoria delle minoranze etniche. Il rapporto tra immigrati e credito in Italia In Italia, alcune iniziative di offerta di credito all’immigrazione sono state condotte da:
Per ulteriori approfondimenti sulla questione cfr. CER, Strumenti del credito e migrazioni |
Oltre agli immigrati per ragioni economiche, sia quelli in fuga da condizioni di svantaggio e provenienti dai paesi in via di sviluppo, sia quelli provenienti dai paesi "ricchi", e spinti dall’internazionalizzazione del mercato del lavoro, dallo sviluppo dei traffici commerciali e dai processi di mobilità, è in netto incremento il flusso di profughi in fuga da situazioni di guerra, da conflitti etnici, da persecuzioni e occupazione militare o paramilitare di territori.
Dal punto di vista fenomenologico non è facile tracciare una rigida distinzione fra le varie tipologie di flussi. I limiti della suddivisione tra migranti per ragioni economiche e profughi nascono per via dello stretto nesso esistente tra situazioni di conflitto sociale, discriminazione politica e carenze di opportunità economiche.
I processi di globalizzazione e lo stesso fluidificarsi dei fenomeni migratori non dirimono, ma al contrario acuiscono, questa indeterminatezza. La distinzione formale dei motivi e delle cause che spingono il migrante a lasciare il proprio paese rischia a ogni passo di irrigidirsi, imbrigliando una realtà che dal punto di vista fenomenico tende a sfuggire e a confondersi: spesso la povertà, ma soprattutto la condizione di deprivazione relativa rispetto alla aspettative dei migranti, danno avvio a una catena di eventi che spingono gruppi di persone a lasciare il proprio paese. Di fatto, il nesso tra povertà economica e migrazioni si constata quasi regolarmente anche fra i flussi di rifugiati. Povertà, tensioni sociali, repressione, violazione dei diritti umani sono meccanismi a catena, che sempre più spesso innescano movimenti migratori di profughi.
Inoltre, i flussi di profughi sono per definizione asistematici e discontinui (assai poco pianificabili da parte di paesi di accoglienza) e si inseriscono all’interno dei canali migratori già costituiti, gravando sulle catene organizzate e spesso illegali o mescolandosi con esse. Ecco perché, recentemente, gli operatori del settore parlano di "flussi misti", alludendo alla loro composizione costituita sia da immigrati per ragioni economiche sia da richiedenti asilo e rifugiati per ragioni politiche.
Pur rappresentando - almeno in teoria - un fenomeno distinto, i rifugiati, si mescolano in modo indistinto nel complessivo e strutturale fenomeno immigratorio in Italia.
La destabilizzazione, cresciuta in seguito alla dissoluzione dell’ordine bipolare, ha portato a un moltiplicarsi quasi incontrollato di microconflitti e si registra un notevole aumento del fenomeno della fuga di masse di popolazioni dalle zone in crisi o in aperto conflitto etnico-politico. L'Italia risente in modo particolare di questo effetto per via della prossimità geografica e storica che la lega alla ex Jugoslavia, all'Albania e alla Somalia, e per via del transito che questi ultimi paesi hanno consentito ad altrettanti flussi di popolazione provenienti da zone in conflitto, quali - recentemente - il Kurdistan e il Kosovo.
All'interno dell’immigrazione in Italia, fenomeno "strutturale" ma poco "strutturato", coesistono varie espressioni di progetti migratori e ragioni, più o meno esplicite e consapevoli, che determinano e giustificano tanto il viaggio, ovvero "l’evento migratorio", quanto lo "star qui", le ragioni di permanenza e la sua connotazione, più o meno definitiva o transitoria. A una fuga repentina e non preventivata, a un voler "cambiare aria" senza chiare aspettative, com’è il caso dei tanti profughi che periodicamente raggiungono il nostro paese, si affianca spesso un vero e proprio viaggio-investimento, iscritto all’interno di un progetto organizzato nei dettagli, e denso di concrete aspettative.
Anche in Italia l’immigrazione costituisce spesso una "vicenda familiare": il "gruppo famiglia" mette in atto vere e proprie strategie, che consentono ai suoi membri di non subire il processo migratorio ma di gestirlo secondo una progettualità e una gerarchia di aspettative, talvolta anche di ampio respiro e che esulano dalla circoscritta esperienza del singolo migrante.
Alcune categorie di immigrati di prima generazione (soprattutto i gruppi provenienti dai paesi più lontani, come i cinesi, i filippini, o i colombiani) conducono in Italia una lunga esperienza mantenendo uno stretto contatto con la famiglia allargata rimasta in patria. Questo legame implica un indubbio reciproco vantaggio: mentre all'inizio il migrante è sostenuto per i costi di permanenza e di inserimento, successivamente diventa agente di sviluppo della propria famiglia attraverso le rimesse e i beni di consumo che invia nel paese di origine. Con una efficace immagine si parla a tale proposito di "famiglia ombra", simbolicamente presente lungo tutto il dispiegarsi del progetto migratorio del singolo.
È giocoforza che il progetto collettivo organizzato dalla famiglia di provenienza diventi progetto per la famiglia futura, riverberandosi necessariamente sul progetto di vita dei figli, nati o nascituri, fino a diventare - loro malgrado - progetto dei figli stessi. Questa questione, carica di conseguenze personali e sociali, apre un nuovo capitolo, legato alla integrazione degli "immigrati di seconda generazione", per sua natura diversa da quella dei genitori e decisamente più complessa. La questione si è presentata solo di recente nel panorama italiano, fino a oggi caratterizzato, salvo poche eccezioni, da una immigrazione di prima generazione, con intensità diverse a seconda delle regioni di inserimento.
Di fatto, gli unici soggetti che rimangono privi di potere decisionale nel progetto migratorio della famiglia, denso di così ampie prospettive e carico di così importanti risvolti a livello personale e sociale, sono proprio i figli dei migranti, che seguendo i propri genitori nella migrazione o rimanendo nel paese di origine affidati alla struttura familiare che sorregge e segue lo sviluppo del progetto migratorio, subiscono il progetto migratorio inaugurato dai genitori.
Nel caso in cui essi seguano i genitori nella migrazione, questa situazione è gravida di conseguenze perché crescono di fatto in uno stato di "semi-estraneità" nei confronti sia della cultura di arrivo sia della cultura di partenza.
La presenza dei minori immigrati, incerta dal punto di vista quantitativo per il fatto che questi non godono di una registrazione autonoma ma sono iscritti sul permesso di soggiorno dei genitori, riveste fra l’altro una fondamentale importanza come indice della propensione degli immigrati a insediarsi stabilmente nel paese.
La distribuzione numerica dei minori di seconda generazione nella scuola italiana, d’altra parte, ricalca grosso modo la geografia delle comunità nazionali presenti nel paese, con le stesse caratteristiche di policentricità e di differenziazione già accennate.
Dallo sviluppo di alcuni dati che collegano la presenza di studenti stranieri al loro passaggio agli studi superiori, si possono ricavare interessanti considerazioni sul grado di integrazione, di inserimento e di stabilizzazione. In particolare si riscontra che solitamente la presenza di studenti stranieri all’università risponde alla combinazione di tre variabili:
- l'anzianità di insediamento delle collettività immigrate;
- il procedere dell'inserimento socio-economico valutato in termini di benessere raggiunto;
- la propensione alla formazione e alla costituzione di nuclei familiari.
Motivi economici, ricongiungimenti familiari, profughi. Così definite, le filiere migratorie, tradizionale appannaggio di competenze acquisite da generazioni di migranti attraverso una pratica consolidata e trasmessa informalmente, non sono però solo prerogativa familiare, è giustificata da motivazioni di carattere affettivo-fiduciario.
La riconfigurazione dei flussi avvenuta in Europa negli ultimi venti anni ha determinato un progressivo blocco dell’immigrazione per lavoro, con conseguente aumento delle forme di immigrazione clandestina illegale o irregolare che determina la sostituzione delle tradizionali filiere migratorie informali o amicali con forme più organizzate e specializzate di "traffico", in grado di mantenere, alle mutate e più impervie condizioni, l’offerta di immigrazione e inserimento nei paesi di destinazione.
Il traffico degli esseri umani, pertanto, operato da professionisti in grado di risolvere i problemi e di oltrepassare i blocchi frapposti dai paesi di destinazione, interessati a frenare e selezionare i flussi di entrata, va inteso innanzitutto come una risposta "strutturale" - anche se illegale e illecita - orientata a ridurre la differenza fra una forte domanda di ingresso, di lavoro e di inserimento nei paesi comunitari e una debole offerta (di ingresso, lavoro e inserimento) da parte dei paesi di destinazione.
Con la chiusura dell’Europa alla immigrazione "da lavoro", in sostanza, si sono sviluppate catene specializzate, gestite da organizzazioni illegali, che, ai fini di un ricavo economico, favoriscono e gestiscono l'ingresso, attuato in modo clandestino, di un consistente numero di cittadini stranieri.
Per via dell'elevata esposizione e vulnerabilità delle sue coste, l’Italia si trova in prima linea, insieme ad altri paesi frontalieri della Comunità Europea, nell’esposizione a queste assai specializzate filiere di immigrazione illegale.
d) Gli irregolari e i clandestini
L’ingresso di flussi di immigrati clandestini è un problema che coinvolge soprattutto l'Italia, la quale per via della esposizione di 8.000 chilometri di coste e della sua vicinanza alle zone critiche del Mediterraneo, risulta un canale di accesso all’Europa particolarmente vulnerabile.
La stima quantitativa degli irregolari risulta imprecisa (250.000 unità, circa 1 immigrato su 7), ed è altresì noto che vi sono interscambi continui e vicendevoli tra la componente degli immigrati regolari e quelli irregolari. Infatti, i primi diventano irregolari alla scadenza del permesso di soggiorno, mentre una buona parte degli irregolari vengono "regolarizzati" di volta in volta grazie ai numerosi provvedimenti approvati dal Parlamento italiano (nel 1987, 1990, 1996 e 1998).
Tuttavia, si deve osservare che la questione dei clandestini, e in generale il problema della irregolarità, risulta comune a tutti i grandi paesi di immigrazione, ivi compresi gli USA e la Germania.
Lo status riconosciuto (o meno) ai migranti dalle istituzioni italiane e i criteri formali che ne determinano l’ingresso concorrono a semplificare il complicato arcipelago dell’immigrazione in Italia in quanto permettono di distinguere gli immigrati regolari dai non regolari. Il discrimine è rappresentato ovviamente dal rispetto delle norme giuridiche che riguardano le condizioni di ingresso e di permanenza nel paese.
L’irregolarità della presenza non integra la fattispecie di un reato, ma costituisce più semplicemente una violazione di tipo amministrativo. Non è dunque la condizione di irregolarità in sé a rappresentare una minaccia alla sicurezza.
Tuttavia, alcuni aspetti legati alle permanenze irregolari, le condizioni e le modalità in cui avviene l’ingresso, i difficili processi di inserimento che i flussi di irregolari mettono in atto sul territorio e nel tessuto sociale italiano, si collegano direttamente della sicurezza, sia personale sia sociale, e con grande facilità danno adito ad allarme sociale. Almeno due sono gli allarmanti aspetti di rischio sociale legati alla presenza di irregolari in Italia:
- la stretta connessione esistente tra l’irregolarità e il traffico di esseri umani, che contribuisce alla crescita e diffusione delle organizzazioni malavitose che vivono di questo commercio e della tratta (scheda 3);
- le condizioni di inserimento sociale e occupazionale dei "non regolari", che risultano spesso coinvolti nei settori dell’economia sommersa, lecita e illecita (scheda 4).
|
Scheda 3 - La tratta degli esseri umani e il traffico a scopo sessuale Persino in alcuni testi di legge e nel dibattito politico non solo italiano in materia, la distinzione terminologica fra "traffico" (smuggling) e "tratta" (trafficking) è inopinatamente sottovalutata, mentre occorre porre una certa attenzione a tenere separati i due fenomeni:
Per quanto riguarda la consistenza della tratta e dello sfruttamento sessuale, le stime sono imprecise per il carattere stesso del fenomeno che presenta un elevato tasso di mobilità. Sulla base degli indici di mobilità geografica, di volontarietà/coercizione e di insediamento urbano o rurale-urbanizzato, si sono finora individuati tre modelli prostituzionali strettamente connessi con la nazionalità di provenienza delle donne coinvolte: quello albanese, quello nigeriano e quello dell’est dell’Europa, ciascuno caratterizzato da diversi livelli di coercizione o relativa autonomia delle vittime di sfruttamento. Il nuovo panorama legislativo, inaugurato dalla l. 40/98 e ripreso dal T.U. 286/98, si occupa del fenomeno, della importazione e dello sfruttamento di prostituzione sia attraverso una disciplina che prevede l’aiuto per le vittime (art. 18) sia attraverso un inasprimento delle sanzioni e la previsione di specifici reati penali per il nuovo reato di tratta. La forma di sostegno per le vittime, in particolare, è basata sul principio di collaborazione con le forze dell'ordine mentre il reato di tratta a scopo di sfruttamento sessuale rappresenta un progresso nella direzione della lotta al fenomeno che finora non era colpito nella sua specificità. È significativo il dato che il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione rappresentano il reato per il quale si è registrata negli ultimi tre anni la quota più elevata di stranieri sul totale dei denunciati (55-56%). Per un’approfondita analisi del fenomeno, della consistenza numerica, dei modelli prostituzionali cfr. F. Carchedi, La condizione degli immigrati in Italia, cap. 6, La prostituzione straniera e la tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale. Dal dossier risulta evidente la singolarità del fenomeno e la sua autonomia dal traffico degli esseri umani. Per l’analisi dei dati relativi alla sicurezza, per la documentazione, anche statistica, dei reati commessi dagli stranieri cfr., invece, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, Migrazioni e sicurezza in Italia, cap. 5, La devianza degli stranieri in Italia. |
|
Scheda 4 - Migrazioni e sicurezza La controversa questione della sicurezza fa comunemente riferimento a tre distinte problematiche:
Sicurezza e stabilità La sicurezza per la stabilità riguarda l’intervento in quei contesti critici da cui possono divampare disordini, sommosse, esodi o in cui risultano a rischio i processi democratici e il rispetto dei diritti umani fondamentali. La connessione fra questi eventi e i movimenti migratori di profughi o rifugiati è più che evidente e una lungimirante politica di pace ha già visto impegnate le risorse dei paesi Europei in varie regioni del mondo. Al processo di unificazione europeo corrisponde un più che naturale avvio di una "politica estera" europea nei confronti, primariamente, delle regioni limitrofe, l’est e il sud-est europeo, e poi l’intero bacino del Mediterraneo. La stabilità delle regioni adiacenti all’Unione è infatti un prerequisito essenziale per la diminuzione dei costi sociali in termini di flussi di clandestini e traffici illeciti. Sicurezza e irregolarità La sicurezza per l’irregolarità riguarda la componente irregolare dei flussi migratori, e cioè sia i clandestini, ovvero coloro che varcano i confini illegalmente, sia coloro che, giunti nel paese di permanenza in modo lecito, continuano a risiedervi senza averne i prerequisiti legali, o perché scaduti, o perché perduti in altro modo. L’irregolarità, oltre a vanificare gli sforzi di pianificazione, gestione e programmazione delle politiche di integrazione messe in atto dai paesi di destinazione, comporta rischi anche per i soggetti direttamente interessati, rendendoli fragili interlocutori nel mercato del lavoro per i diritti civili riservati ai cittadini e ai regolari e per la loro stessa possibilità di far valere i propri diritti contro terzi. Ecco perché, al di là delle inadempienze formali direttamente legate all’irregolarità, gli irregolari sono più spesso coinvolti in attività criminose di quanto non avvenga per i regolari, come soggetti più vulnerabili e disponibili a un inserimento anche illegale nel contesto di destinazione. Sicurezza e criminalità La sicurezza per la criminalità riguarda la questione della correlazione fra criminalità e immigrazione, che in Italia ha prodotto negli ultimi anni studi e analisi di vario tipo. La correlazione fra andamento delle statistiche giudiziarie e penitenziarie da un lato e presenze immigrate dall’altro si spiega in realtà soprattutto con altre variabili intervenienti. La condizione di irregolarità soprattutto, che da sola sposta su di sé la correlazione tanto dei crimini (commessi o presunti) quanto della carcerazione (assai spesso preventiva). Anche la composizione, per età, sesso, stato civile, titolo di studio, la condizione abitativa e occupazionale degli immigrati, oltre alle condizioni disagiate di vita, incidono maggiormente sulla propensione al crimine e ai comportamenti devianti di quanto non sembri fare la condizione di immigrato in quanto tale. Sull’argomento si raccomanda in particolare il dossier del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, Migrazioni e Sicurezza in Italia. |
Corollario di entrambi gli aspetti è la vasta diffusione di criminalità indotta, sotto forma di contrabbando, racket, sfruttamento della prostituzione e di crescente internazionalizzazione di bande abitualmente dedite ad attività criminose. Per questi motivi la condizione di irregolarità è stata oggetto di una particolare attenzione da parte del legislatore italiano che vi ha dedicato, oltre a una chiara disciplina contenuta nella l. 40/98, diverse integrazioni a mezzo di decreti legislativi (d.l. del 19 ott. 1998 n° 380 e d.l. del 9 aprile 99).
2. L'"integrazione": ruolo dello Stato e degli enti locali
2.1 Dai "due pedali" al modello della "transizione accompagnata"
Nella "risposta italiana" all’immigrazione possono essere colti due approcci rispetto alla integrazione socio-culturale:
- l'integrazione come assimilazione, ossia, come processo che porta gli immigrati a condividere totalmente valori della cultura nazionale;
- l'integrazione come espressione di multiculturalismo, dove il riconoscimento delle diversità e specificità degli immigrati è il primo valore a essere condiviso.
Si tratta, ovviamente, di due modelli ideali e astratti, che comunque, sembrano percorrere trasversalmente, con svariata intensità e costante commistione, tutti i comparti del sistema sociale italiano, da quello occupazionale a quello logistico e abitativo, dall’amministrazione sanitaria alle politiche dell’istruzione, dagli strumenti della rappresentanza al funzionamento degli apparati della giustizia e della sicurezza.
Lo spettro delle scelte politiche poste dai due modelli spazia dalla promozione/difesa degli interessi/diritti garantiti a tutti, in quanto "universali", al riconoscimento delle differenze sostanziali, cui corrispondono un diritto soggettivo e un "dovere pubblico", che dipendono dallo status giuridico dei singoli.
In entrambi i casi il contesto normativo italiano evolve nel corso degli anni alla ricerca di un equilibrio che appare dinamico e in perenne ridefinizione. Tale evoluzione è ispirata anche alle esperienze di altri paesi europei, in cui si individuano percorsi di inclusione degli immigrati sulla base dell'affermazione di diritti e di doveri di tutte le parti in causa (stranieri, cittadini autoctoni, istituzioni pubbliche, enti, associazioni) e nel rispetto delle specificità culturali e religiose. In Italia tuttavia il modello che va consolidandosi è, in un certo senso, una originale e flessibile strategia di accompagnamento della transizione, orientata a una graduale familiarizzazione del sistema alle fenomenologie emergenti, piuttosto che alla decisa applicazione di un modello di integrazione precostituito.
Lo dimostra il fatto che, dal 1986, si sono succeduti a livello normativo ben quattro interventi di legge o decreti che, anche attraverso periodici interventi di sanatoria e regolarizzazione, hanno contribuito a creare un quadro particolarmente articolato e complesso della questione. Soltanto recentemente, grazie alla legge 40/98, confluita nel Testo Unico (T.U.) 286/98, e ai successivi decreti integrativi, il paese ha intrapreso la strada verso una maggiore stabilità normativa, dovuta a una più forte coerenza interna del sistema e all’ormai diffuso riconoscimento che la questione dell'immigrazione e delle relative politiche debba consistere in un work in progress, soggetto dunque a continui aggiornamenti.
L'immigrazione italiana è fenomeno ancora strettamente legato al lavoro. Anche se tra i nuovi ingressi è in aumento la quota di minori e anziani che si ricongiungono ai familiari emigrati, la maggior parte dei nuovi venuti sono persone in età lavorativa e in cerca di occupazione. Per quanto si pensi comunemente che l'avvento degli immigrati abbia sconvolto o almeno influito fortemente sulla realtà socio-lavorativa del paese, è piuttosto vero il contrario, cioè che gli immigrati si sono inseriti nel mercato del lavoro italiano, con le sue caratteristiche strutturali, condividendone tanto i vizi quanto le virtù. Questa affermazione vale sia per i settori di impiego, da quello dei servizi a quello industriale o agricolo, che per le modalità di inserimento, formale, informale, irregolare, stabile o precario e - molto recentemente - anche interinale.
Con tutti i limiti di una definizione per grandi linee, gli immigrati sono occupati al Nord nel settore industriale, e al Sud nell'edilizia e nell’agricoltura. Il dato più caratterizzante e più sintomatico è costituito dal tendenziale aumento dell'offerta di occupazioni precarie e temporanee e alla diminuzione del lavoro in fabbrica, in uno scenario - non solo italiano - in cui quest’ultima non rappresenta più un traino al modello di sviluppo socioeconomico.
Il paese non applica un chiaro criterio di selettività nella definizione delle quote di immigrati per motivo di lavoro: tali quote vengono stabilite sulla base di una concertazione politica che tiene conto solo parzialmente delle esigenze del tessuto produttivo del paese, e ancor meno delle caratteristiche dell’offerta di lavoro da parte degli immigrati, per competenza, entità, composizione.
Recentemente, si è aggiunto un altro criterio, più vicino alla logica della cooperazione internazionale, e in cui, attraverso la ratifica di patti internazionali e bilaterali che l’Italia ha stipulato con alcuni paesi di emigrazione, quali l’Albania, la Tunisia, il Marocco, si cerca di rendere più efficaci i respingimenti e le espulsioni di presenze irregolari o indesiderate sul territorio italiano e si negoziano coi paesi di provenienza quote di immigrazione idonee a rispondere alle richieste dal mercato del lavoro interno.
Si pone la necessità urgente di trovare formule e modalità di maggiore rigore nella programmazione dei flussi, anche in funzione delle pressioni dai contesti di provenienza. E ciò allo scopo di promuovere e favorire l’ingresso di manodopera più qualificata e di prestare maggiore attenzione alla connotazione territoriale dei fabbisogni per promuovere con maggior efficacia i processi di incontro della domanda e dell’offerta e ridurre, al tempo stesso, l’immissione irregolare di immigrati.
Per far fronte ai massicci afflussi di profughi che rendono impraticabile l’esame individuale delle singole domande, lo Stato italiano è stato indotto ad adottare provvedimenti straordinari di protezione temporanea per i profughi. I permessi temporanei per motivi straordinari rappresentano in questo senso uno sforzo che il paese ha compiuto per inseguire un fenomeno i cui toni risultano talvolta particolarmente indistinti e per convergere, contemporaneamente, sulle linee direttive delle normative internazionali in materia di asilo.
L'Italia regola attualmente la complessa materia dell’asilo con l’articolo 1 della legge Martelli e Dpr 136/90, che definisce le procedure di eleggibilità, e non si è ancora dotata di una legge organica. Un disegno di legge in materia è pendente da lungo tempo presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera.
Nel frattempo, l’accumulo delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato presso la Commissione competente, unica su tutto il territorio nazionale e con sede a Roma, aggrava le già difficili condizioni di coloro che sono in attesa del provvedimento. A un allungamento dei tempi di attesa (in media un anno) non corrisponde un adeguamento legislativo dei termini di assistenza economica, che rimane ferma al termine massimo di 45 giorni. A ciò si aggiunge il fatto che il permesso di soggiorno concesso ai richiedenti asilo non consente di svolgere attività lavorative, né dà accesso a corsi di formazione regionale, comportando quindi una "scopertura" nei processi di inserimento per questa categoria di stranieri e un rischio in termini di impatto sociale.
Nemmeno la recente adesione dell’Italia alla convenzione di Dublino trova entusiasti gli operatori del settore. Pare pertinente l'osservazione che rileva con quanta solerzia e organizzata sistematicità alcuni paesi (ad esempio la Germania) applichino e interpretino la convenzione nel senso più restrittivo a danno dell'Italia, porta per l'Europa di numerosi e copiosi flussi. Tale applicazione accresce infatti le già difficili condizioni di inserimento dei profughi nei paesi di accoglienza: i cosiddetti respinti di Dublino, costretti a rimanere in Italia, subiscono fra l’altro inserimento in un paese che, nella maggior parte dei casi, non è quello di loro scelta.
Oltre all’inserimento nel mercato del lavoro e le procedure di asilo per i rifugiati, altri sono i settori di accesso che servono da strumenti per una politica di integrazione degli immigrati in Italia: dalle questioni dell'alloggio a quelle della sanità, dall’istituto della pubblica istruzione a quello della partecipazione alla vita pubblica. I dossier proposti hanno a vario titolo affrontato in dettaglio ciascuna di queste dimensioni.
I processi insediativi degli immigrati nelle città italiane hanno portato alla luce, se ancora ve ne fosse bisogno, il problema dell’inadeguatezza del mercato degli alloggi a prezzi sociali o calmierati. L’aumento rapido dei ricongiungimenti familiari e la richiesta di alloggi anche da parte della nuova immigrazione contribuiscono ad accrescere una situazione di per sé strutturalmente in crisi. Le politiche pubbliche e le iniziative locali di comuni, cooperative e associazioni di volontariato si sono rivelate utili ma insufficienti a risolvere il problema.
Gli effetti di questa carenza si riverberano nelle modalità di accesso degli immigrati al reperimento di alloggi nel mercato libero, dove le forme già tipiche del disagio abitativo assumono i contorni della discriminazione. Le disfunzioni più ricorrenti sono legate allo sfruttamento (affitto degli alloggi a canoni esosi, sensibilmente più alti di quelli normalmente applicati ai cittadini italiani), al sovraffollamento (monolocali abitati da famiglie intere; convivenze difficili e a rischio soprattutto per i minori coinvolti) e all’esclusione (alloggi degradati).
Nel quadro appena delineato la recente normativa lascia spazio alla creazione di alloggi per gli immigrati, sperimentata negli ultimi anni a livello locale in vari contesti. Occorre inoltre considerare come positivo il segno dato dal crescente numero di datori di lavoro che, in concorso con le istituzioni e le forze sociali locali, si sono resi disponibili alla realizzazione di alloggi da destinare agli immigrati e alle loro famiglie, anche se la questione meriterebbe un doveroso approfondimento sul versante delle garanzie offerte dalle politiche sociali.
Particolare considerazione e attenzione politica specifica va data al crescente fenomeno del costituirsi e consolidarsi di quartieri connotati da una massiccia presenza di immigrati: si pensi ai noti casi del quartiere di S. Salvario a Torino o al quartiere dell’Esquilino a Roma. A fronte della popolazione immigrata (sarebbe scorretto parlare di "ghettizzazione") è doveroso considerare anche le varie esperienze di integrazione rispettosa dei ritmi, dei modi, delle usanze, della cultura di provenienza. Sembra ancora troppo presto per parlare, in Italia, di quartieri etnici o etnicamente connotati, ma il trend in tal senso è già evidente.
Ancora una volta sono la dimensione territoriale e l’amministrazione locale che hanno dimostrato di saper interpretare con pronta flessibilità le esigenze provenienti dal corpo sociale, stimolando conseguenti positive risposte (in termini di pulizia, ordine, sicurezza, quieto vivere, qualità della vita, ecc.) da parte della popolazione immigrata e autoctona. Nelle politiche abitative quindi, più che altrove, il modello flessibile dell’adattamento progressivo "dal basso" sembra essere, a tutt’oggi in Italia, il più efficace.
Il settore della sanità si presenta come particolarmente complesso: la tutela della salute, infatti, è da una parte manifestazione della tutela di un diritto individuale, che può essere più o meno riconosciuto e garantito universalmente, e dall'altra espressione del diritto-dovere dello Stato di sorvegliare e monitorare il livello di salute generale della collettività.
La copertura sanitaria degli immigrati ha conosciuto una evoluzione assai rilevante negli ultimi anni, passando attraverso gli stadi della frammentazione nell’applicazione territoriale e della discontinuità nel tempo. Difatti, la protezione dei diritti della salute, legati allo status giuridico-legale dei beneficiari, regolari o irregolari, è stata diversamente interpretata dalle legislazioni regionali, che in alcuni casi destinano provvedimenti positivi e benefici assistenziali alla categoria degli immigrati, in altri alla categoria degli stranieri, in altri ancora a quella di "soggetti deboli", nella quale rientrano gli immigrati/stranieri.
La questione assume una complessità ancora maggiore se si pensa che, a questa discontinuità normativa, si sono aggiunti problemi come la mancanza di conoscenza dei propri diritti da parte degli immigrati e la diffidenza degli immigrati stessi nei confronti dell'assistenza sanitaria e del ricovero ospedaliero, vuoi per il timore che emerga la condizione di irregolarità, vuoi per diffidenza nei confronti della medicina occidentale, vuoi per le difficoltà che lo stesso personale medico mostra in alcuni casi quando si confronta con esigenze diverse da quelle degli occidentali (scheda 4).
L'attuale risposta pubblica è frutto delle considerazioni basate sull’esperienza e sull'evoluzione di regolamenti e circolari seguite al d.l. 489/95 (Decreto Dini), che aveva esteso il quadro dei diritti offerti agli stranieri, slegandolo dallo status giuridico di regolarità o irregolarità. Attualmente la legge (art. 35) riconosce la tutela della salute dei cittadini stranieri irregolari, nella misura in cui offre "cure urgenti" e "continuative... a salvaguardia della salute individuale e collettiva", garantendo in particolare gli interventi di profilassi e le vaccinazioni, nazionali e internazionali, la tutela della salute del minore e la tutela della gravidanza e della maternità.
La strada seguita in sostanza è stata quella di camuffare le cure mediche agli immigrati in prestazioni sanitarie urgenti e per maternità, per giungere poi, con il decreto Dini e con la attuale legge, a un allargamento del riconoscimento del diritto alla salute degli irregolari.
In definitiva, come avviene in altri comparti (come l’istruzione), che risultano strategici per i processi di integrazione, la normativa relativa alla assistenza sanitaria per gli stranieri irregolari è il frutto di un’evoluzione che, passando attraverso circolari o decreti di "transito", ha di fatto concorso a promuovere e a far prevalere la tutela di alcuni valori fondamentali e inviolabili della persona sul diritto "di carta", infiltrandosi, ove possibile, tra le maglie della legge.
|
Scheda 5 - La medicina delle migrazioni in Italia I termini della questione L’emigrazione impone a chi intraprende il progetto migratorio dei costi, non solo economici ma anche fisici. Gli immigrati che entrano nel nostro paese, poggiando la riuscita del proprio progetto migratorio principalmente sulla propria forza-lavoro, solitamente giungono con un "patrimonio" di salute pressoché integro, effetto dell’autoselezione che precede la scelta migratoria: in letteratura si parla di "effetto migrante sano". Tuttavia, una serie di fattori rappresenta un particolare rischio per la salute degli immigrati.
Questi sono:
I limiti del momento L’incontro tra l’offerta sanitaria e la richiesta di assistenza sconta alcuni limiti dovuti alla persistenza di barriere amministrative, economiche, organizzative, linguistico- comunicative e culturali nell’accesso ai servizi. In particolare, si riscontrano:
Un diverso approccio Nell’ultimo secolo la medicina occidentale ha cominciato a occuparsi sempre più di malattie e sempre meno di pazienti. Di fronte al malato immigrato, in particolare, le "distorsioni" più frequenti riguardano la valutazione della differenza culturale (sopravvalutazione o sottovalutazione). Nei confronti di pazienti immigrati l’anamnesi e la diagnosi sono influenzate ora dall’una ora dall’altra cultura e si riconoscono due casi o fasi: la fase, cosiddetta, dello scetticismo sanitario, dove la differenza culturale viene invocata a spiegare situazioni di fronte alle quali il medico occidentale si sente disarmato, e la fase dell’esotismo, ribattezzata della "sindrome di Salgàri", in cui il medico và alla ricerca di patologie tropicali studiate negli anni di università sui libri di malattie infettive, e inesistenti nella maggior parte dei casi come patologie d’importazione. Agli operatori sanitari e medici, che si confrontano con questo processo transculturale, si richiede un rovesciamento del tradizionale rapporto medico-soggetto/paziente-oggetto, riconoscendo a entrambe le parti un duplice ruolo all’interno della relazione di cura.
Un’indagine accurata delle patologie degli immigrati in Italia, delle politiche sanitarie nei confronti degli stranieri e dell’incontro tra culture in medicina in Caritas di Roma, S. Geraci, M. Marceca, M. Mazzetti, Migrazioni e salute in Italia. |
c) L’istruzione
Il settore dell'istruzione interessa da vicino una delle categorie chiave del processo di integrazione degli immigrati in Italia: quella dei minori immigrati, comunemente definiti immigrati di seconda generazione oppure - con espressione fortemente evocativa - "generazione del sacrificio".
È evidente l’importanza che assume, in questo scenario, la scuola come contesto di inserimento culturale, oltre che come strumento per l’integrazione sociale. Il sistema scolastico rappresenta, per i minori, quello che per gli adulti rappresenta il contesto di lavoro: il primo e principale ambito di inserimento nel tessuto sociale. La scuola, sia attraverso la formazione culturale, sia attraverso i legami che essa genera, è alla base della costruzione della identità sociale, personale e collettiva dei minori e, di rimando, delle famiglie a essi legate.
La strada tracciata dalla scuola, per garantire l’istruzione a tutti e aprirsi anche ai minori irregolari o figli di irregolari, è passata così per il sistema sanitario, attraverso tappe progressive, con l'accoglienza iniziale degli stranieri come "uditori", poi come "provvisori" e infine come iscritti "con riserva in attesa di regolare la propria posizione".
Dagli studi condotti emergono tuttavia alcuni rischi, di cui il sistema della scuola si può rendere inavvertitamente protagonista e che penalizzano il minore immigrato, generando un meccanismo di esclusione e persino di "razzismo istituzionale". È quanto emerge dal sottile carattere discriminatorio che si riscontra in alcuni libri di testo non aggiornati, che presentano una immagine stereotipata dell’emigrazione, intrisa di toni allarmati o - peggio - di pregiudizi, del tipo di quelli utilizzati dalla stampa.
Rispetto al concreto processo di inserimento scolastico, inoltre, si riscontra la difficoltà del corpo docente a dare una giusta interpretazione agli indirizzi programmatici in materia di didattica interculturale: d’altronde il sistema scolastico italiano, carico di rigidità, arretratezze istituzionali e basso livello motivazionale del personale docente, è anche ricco di iniziative coraggiose e intraprendenti, che spesso però rimangono sconosciute e isolate.
Altro fondamentale strumento di integrazione è la partecipazione alla vita pubblica nei contesti di insediamento e la rappresentanza degli interessi nella società e nei luoghi di lavoro degli immigrati. La carenza o la mancanza di partecipazione, oltre a rappresentare il sintomo di una cultura dell'accoglienza "claudicante", rischia di generare una complessiva immaturità civile degli immigrati, che non è certo da augurarsi.
Né - a giudizio di alcuni dei dossier proposti - l'esperienza delle Consulte per l'immigrazione ha prodotto una effettiva partecipazione politica, sia a livello nazionale sia a livello regionale e locale. Le Consulte hanno manifestato problemi legati alla debolezza di impatto sulle amministrazioni locali, nonché limiti strutturali interni, quali la natura esclusivamente consultiva dei loro pareri, criteri di eleggibilità e designazione dei partecipanti poco trasparenti, nonché la mancanza di un riscontro istituzionale alle indicazioni fornite. È peraltro orientamento condiviso che l'esperienza delle Consulte si ponga su un piano pre-politico, pertanto limitata nelle sue espressioni. Per questi motivi uno degli obiettivi prioritari posti dalla legge Turco-Napolitano n° 40/98 consiste proprio nell'incrementare le opportunità di partecipazione sociale e culturale della popolazione immigrata.
L’argomento è peraltro fortemente dibattuto e molto controverso soprattutto per quanto riguarda il diritto al voto amministrativo. Una proposta di revisione costituzionale muove nella direzione della modifica dell'articolo 48 Cost., che nel suo stato attuale preclude la strada al riconoscimento del diritto al voto agli stranieri. Esso appare particolarmente delicato - analogamente a quello del diritto di voto per gli italiani residenti all’estero - anche per gli indubbi interessi che la questione proietta sul mondo politico e delle forze sociali presenti sulla scena italiana.
Nelle more di una disciplina dettagliata, gli statuti di alcuni comuni italiani (Torino, Bologna e, in parte, anche Roma) hanno consentito la partecipazione degli stranieri ai Referendum consultivi, grazie alla previsione di nuove forme di partecipazione popolare contenute nella legge per le autonomie locali (l. 142/90). Tali disposizioni, di chiaro valore simbolico, hanno l'indubbio merito di fare avanzare il dibattito sulla concessione agli stranieri del diritto di voto nelle consultazioni amministrative.
Dato il carattere di progressiva stabilizzazione del fenomeno migratorio, l’inserimento positivo di molti immigrati nel mondo del lavoro in diverse regioni e la crescente presenza di nuclei familiari e di minori, sia immigrati sia nati in Italia, pare superfluo ribadire il significato sociale e politico dell'ammissione degli stranieri, titolari di carta di soggiorno, all'elettorato attivo e passivo. Nel complesso, il riconoscimento del diritto al voto sembra aver intrapreso la strada di una progressiva definizione, analoga a quella illustrata per altri diritti nei settori della sanità e della scuola, e attraverso lo stesso modello di transizione e di impulso locale, cui più volte si è accennato.
Altrettanto fermento si osserva sul tema della semplificazione amministrativa e della modifica delle condizioni per il riconoscimento del diritto di cittadinanza agli stranieri, da lasciare all'attuale criterio del jus sanguinis, ma contaminato da alcuni elementi di jus soli. L’Italia non sembra ancora peraltro aver maturato una propria posizione sulla rappresentanza delle minoranze etniche, categoria sociale di sicuro incremento nei prossimi anni. Le istanze (religiose, culturali, valoriali e a vario titolo politiche) delle minoranze etniche non sono destinate certo a coincidere con le basilari rivendicazioni di "accesso" della indistinta popolazione dei "non cittadini", di fatto residenti in Italia. Una certa distanza sembra ancora sussistere fra diritto "formale" e diritto "reale" nei pochi esperimenti di rappresentanza delle minoranze etniche, e continua a percepirsi una certa confusione fra "diritti degli stranieri" e "pari opportunità e accesso" delle minoranze.
Nel contesto finora delineato di evoluzione dal basso e di aggiustamento progressivo e flessibile della tortuosa via italiana all’integrazione, i nuovi veri protagonisti sono le regioni e gli enti locali. Sono loro, nei fatti, gli interlocutori privilegiati e responsabili del processo di integrazione degli immigrati nel nostro paese.
La generale distribuzione delle competenze tra il livello centrale e quello locale è in questi anni in rapida evoluzione, con una evidente tendenza, a velocità diverse, al decentramento e controbilanciati spostamenti di alcune competenze sul livello sovranazionale, cioè europeo. Per varie ragioni nella gestione dell’immigrazione la questione è più complessa e la definizione dello status di straniero rientra ancora tra le prerogative statali. Ma nel futuro è attendibile che un cambiamento rilevante si verifichi proprio sotto questo profilo, con uno spostamento di competenze sul livello europeo.
Del resto - come è stato efficacemente descritto - si può fare riferimento a due esigenze nelle politiche di integrazione:
- l'integrazione "sistemica", intesa in termini di controllo, prevenzione e sicurezza, e affidata al livello nazionale e, nel futuro, a quello sovranazionale;
- l'integrazione sociale, che si definisce residualmente ed è affidata al livello locale.
Al di là degli intenti la risposta alle questioni urgenti, reclamata a gran voce dalla richiesta di riconoscimento del carattere universale di certi diritti (in particolare, diritto alla salute e all'istruzione) è stata fornita fino a oggi soprattutto dall'intraprendenza di "coraggiosi" enti locali. E una notevole parte delle politiche di integrazione, nelle more e nei ritardi della legislazione nazionale, si è sviluppata e affermata presso le realtà locali per tacita delega e grazie al generoso contributo delle associazioni di volontariato e alla costruttiva collaborazione degli enti locali stessi.
Il modello di transizione accompagnata dal basso tuttavia - come è stato osservato - non va visto come un processo senza problemi e non ne vanno enfatizzati eccessivamente i traguardi raggiunti. Spesso, anziché accelerare i meccanismi di integrazione e di promozione dei diritti degli stranieri, il monopolio del locale ha chiuso le porte alla "sfera di titolarità di alcuni fondamentali diritti civili, sociali e politici importanti per un’integrazione attiva e non subordinata", abituando il legislatore nazionale a intervenire in materia di immigrazione solo sull'onda di "spinte forti" e di situazioni di emergenza.
È vero che la tendenza a sottovalutare per lungo tempo la strutturalità crescente del fenomeno ha lasciato le regioni, gli enti locali e le organizzazioni di solidarietà da soli nella gestione della montante complessità della realtà sociale di loro spettanza, sia per quanto riguarda la comunità immigrata sia per quella autoctona.
Le associazioni di volontariato hanno del resto sviluppato vere e proprie politiche di settore e si sono sempre più appropriate della progettazione dei servizi e della loro gestione diretta per assicurare agli stranieri una rete di protezione sociale: in tal modo però si è consolidato nel tempo un ruolo di "amministrazione parallela" ufficiosa e di supplenza.
Il vantaggio derivante da questo processo è evidente nel momento in cui si considera che ha garantito maggiore aderenza alle reali esigenze degli immigrati e soprattutto se si pensa al fatto che il settore affidato al privato sociale ha potuto sperimentare servizi privi dei requisiti ritenuti indispensabili dallo Stato. I limiti consistono nella vischiosità, duplicazione e sovrapposizione di competenze, nell’assenza di un coordinamento sia orizzontale sia verticale, nello sfrangiamento e scarsa potenza d’urto delle politiche di integrazione e nel concreto rischio di intervenire sempre in ritardo ed ex post.
Un sano processo di crescita, pertanto, dovrebbe riuscire a fondere in modo virtuoso i vari livelli di competenza, sapendosi muovere tanto dall’emergenza e dalle esperienze solidaristiche spontanee quanto da una programmazione più ponderata e integrata degli interventi, promuovendo concretamente, in un rinnovato quadro legislativo, politiche efficaci a garanzia dei diritti civili fondamentali.
Ancora molto c’è da lavorare per alimentare il senso di un riconoscimento dei fondamentali diritti di cittadinanza civile e sociale e per permettere che la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica sia messa in grado di offrire il proprio contributo positivo.
Resta significativa la modalità dell’intervento e del processo di implementazione delle politiche nazionali, che segue un iter dal basso verso l’alto, la cui strada è stata sicuramente aiutata dai numerosi esempi che provengono dal settore no profit.
Molti fra i dossier proposti, del resto, permettono di leggere tra le righe la sempre più impellente esigenza di integrare nel nostro paese questo processo dal basso con assetti istituzionali in grado di coordinare le due dimensioni dell’amministrazione:
- quella orizzontale, sotto forma di un’Agenzia in grado di coordinare le istanze sul territorio, fluidificare la vischiosità dei soggetti e ridurre le sovrapposizioni di competenza;
- quella verticale, come luogo istituzionale della rilevazione delle istanze provenienti dal territorio e nel funzionale coordinamento delle competenze centrali.
La prossima più importante tappa che il sistema italiano ha di fronte per rispondere alle sfide indotte dal fenomeno immigratorio sembra proprio consistere, a valle di una riforma normativa già innescata, nel riassetto istituzionale dell’intero comparto, attraverso una corretta manutenzione di entrambe le dimensioni accennate.
